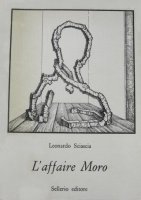Insondabile abisso / ove bellezza nasce da sconcezza, / da efferata dismisura la misura, / da disgrazia / la grazia.
G. Testori
«Io, critico – veramente – critico, mai fui; né, tanto meno, lo risulto e lo sono, adesso». Così dichiara Giovanni Testori in quella prefazione sui generis che introduce il pregiato libro edito da Franco Maria Ricci nel 1989 in riferimento alle «schede-poematiche» o «schede-versicoli», recentemente ripubblicate per i Classici Bompiani, che accompagnano le diverse raffigurazioni della Maddalena, dando vita a un singolare percorso, a un «maddalenesco tragitto», che si dispiega attraverso il dialogo tra immagini e parole.
Queste originali critiche in forma di poesia trovano posto nell’ultimo volume delle Opere (Vol. 3, Classici Bompiani, Milano, 2013) accanto agli scritti venuti alla luce tra il 1977 e il 1993, anno della morte dell’autore, fino ad oggi difficilmente reperibili, trattandosi di testi inediti o pubblicati soltanto in una prima edizione, come nel caso di quelli che introducono cataloghi d’arte, plaquettes, edizioni a tiratura limitata, e che qui ci interessano.
Testori non abbandona la forma del saggio, all’apparenza canonica, tuttavia non può fare a meno di trasformarla, per una sorta di necessità esistenziale, in un racconto-incontro di cui egli resta sempre, quantomeno, attore co-protagonista. Nella sua ricerca di umane consonanze non può sfuggire al bisogno di avere con l’opera e l’artista un contatto quasi carnale, un ‘corpo a corpo’, indispensabile per giungere ad una comprensione che sia davvero profonda, eppure, da critico, non è mai dimentico dei fatti concreti dell’arte, rifuggendo da astratte generalizzazioni, memore anche dell’insegnamento longhiano.