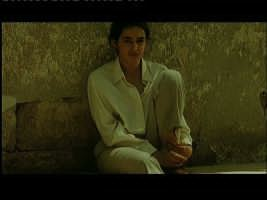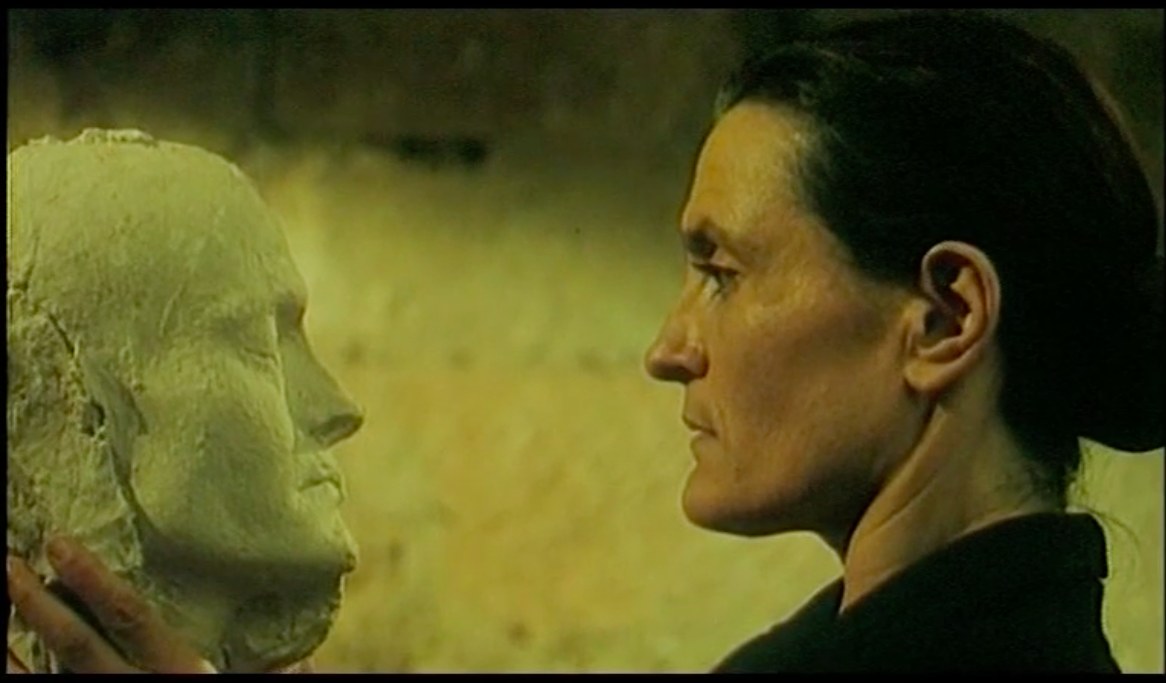Una giovane donna di voraci e disordinate letture, quasi un’autodidatta, nata e cresciuta in un villaggio remoto, si immagina e si fa scrittrice, sottraendosi ai copioni destinati da tempi immemori al suo sesso e affermandosi con insospettabile forza nel panorama letterario internazionale. Raccontata così, ridotta all’osso, la parabola di Grazia Deledda somiglia straordinariamente a quella di una Emily o Charlotte Brontë, e ai miei occhi appare come uno splendido e promettente soggetto cinematografico. Eppure nessun film narra la sua vita e, diversamente dalle intrepide inglesi, persino sul versante letterario mi pare che la figura e le opere della scrittrice nuorese siano state tramandate attraverso un filtro di minorità, accompagnate da un sapore di inservibili anticaglie folcloristiche dalle quali è prudente stare alla larga. Occorre attendere …con amore, Fabia (1993), esordio alla regia di una giovane autrice sarda, Maria Teresa Camoglio, per poter vedere sugli schermi la storia di Deledda, traslata in un racconto di donne distanti nel tempo ma vicine nello spazio simbolico della relazione femminile. Il film è liberamente tratto da Cosima (1937), romanzo autobiografico, pubblicato postumo, di Grazia Deledda. ‘Liberamente’ è un avverbio ambivalente, giacché da un lato autorizza letture nel senso di un cauto allontanamento dal testo letterario, ridotto a puro pretesto, che Camoglio modernizza e stravolge; dall’altro lato, ed è questa la mia proposta, suggerisce la strada di una rielaborazione ampia nel segno della libertà femminile, di una autonomia piena ma non dimentica della sua origine. Così prende forma un testo filmico del tutto personale e, al contempo, intimamente pervaso dalla sua matrice letteraria, coniugata al presente e declinata a partire da sé in un racconto che, attraverso la vocazione artistica e le vicissitudini di Fabia, intreccia le biografie di Cosima, della scrittrice e della stessa regista.
In occasione dell’edizione 2016 del Premio Fiesole ai Maestri del cinema, assegnato a Stefania Sandrelli, è apparso per i tipi di ETS, grazie alla cura di Daniela Brogi, un volume collettaneo che rinnova con grande efficacia l’idea che regista e attore «creano, loro stessi, il testo»,[1] secondo una reciprocità di azioni spesso fraintesa, quando non addirittura misconosciuta. Il settantesimo compleanno della diva, insieme ai suoi cinquantacinque anni di carriera, offriva del resto l’opportunità di riavvolgere il nastro della storia cinematografica del nostro paese, se è vero – come si legge nel suo sito ufficiale – che lei può essere considerata «il termometro del cinema italiano».
Il volume si aggiunge al catalogo di studi recenti dedicati al ‘cinema delle donne’,[2] come si intuisce facilmente già dal titolo. L’evidente riferimento a Balász, lungi dall’essere solo il frutto di un divertito scambio di genere, sposta l’attenzione su un nuovo paradigma femminile che non si riduce alla mera esibizione dei segni del corpo, ma ripropone il tema della visibilità come chiave di volta della «direzione delle immagini» filmiche e al contempo invita a un rinnovato interesse per quelli che Dyer definisce i «segni di performance».[3] Detto altrimenti, con le parole della curatrice, è in un duplice senso che Stefania Sandrelli può essere definita la «donna visibile»: