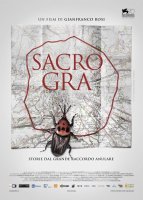1. Benjamin, o dell’avventura
Gli amori difficili sembra essere il libro di Calvino più amato dai registi: nel corpus, in verità assai smilzo se rapportato alla produzione dell’autore e al suo successo internazionale, degli adattamenti cinematografici la maggior parte proviene da questa raccolta: nel 1962 Mario Monicelli trasporta L’avventura dei due sposi nel primo dei quattro episodi di Boccaccio ’70 (vale a dire Renzo e Luciana); l’anno dopo Nino Manfredi gira L’avventura di un soldato (sempre come episodio, questa volta de L’amore difficile); nel 1973 per la televisione tedesca (la ZDF) Carlo di Carlo realizza dall’Avventura di un lettore l’Abenteuer eines lesers; in Messico, dieci anni dopo, Ana Luisa Liguori gira il cortometraggio Amores dificiles.
Infine, nella tarda serata di sabato 9 aprile 1983, la Terza Rete Rai, all’interno del ciclo 10 registi italiani, 10 racconti italiani, manda in onda Avventura di un fotografo, girato, scritto e montato da Francesco (Citto) Maselli. È un lungometraggio particolare, forse fra i più singolari di Maselli (certamente il più interessante fra le trasposizioni degli Amori), e molto distante dal formato dello sceneggiato televisivo tratto da un’opera letteraria: si tratta di un film quasi muto, in cui alle parole molto più spesso si sostituiscono leitmotiv musicali e primissimi piani e l’azione si sfilaccia nella stasi dei personaggi chiusi all’interno di un ambiente domestico. Non è la prima volta che Maselli si confronta con un adattamento, già nel 1963 aveva portato sullo schermo Gli indifferenti di Moravia, nel 1980 realizza quattro puntate televisive da Tre operai di Carlo Bernari e proseguirà con Il compagno di Pavese nel 1998. Esperienze che fanno ben presto maturare nel regista la consapevolezza che «realizzare per immagini un testo letterario è evidentemente scrivere un altro testo»,[1] e in particolare quando si ha a che fare con un racconto così poco narrativo (tanto che nasce, a sua volta, come trasposizione del saggio del 1955, La follia nel mirino).[2] Non a caso le strategie messe a punto tre anni prima con Tre operai, nel caso di Calvino, vengono rovesciate: qui Maselli «tramuta i limiti del piccolo schermo in un’occasione per imbastire un racconto incentrato preminentemente sul materiale plastico e su apparecchiature meccaniche, che contendono ai personaggi in carne e ossa il primato».[3] Il racconto di Calvino, infatti, nella forma di una quête conoscitiva non fa altro che mettere alla prova (questo è il senso proprio dell’avventura del titolo) una serie di possibilità (tutte destinate al fallimento fino all’ultima paradossale soluzione) per catturare e conoscere la realtà attraverso la fotografia e, di conseguenza, per «rappresentare, razionalizzandola, la separazione dal reale che costituisce il nucleo tematico della raccolta e di ogni singola “avventura”».[4] La soluzione a questa «questione di metodo»,[5] com’è noto, è fotografare altre fotografie: ma non si tratta di una mise en abyme o di un approdo alla follia del personaggio, come pure spesso è stato detto. È la scoperta, piuttosto, di un metodo combinatorio che si basa sulla casualità (il caso, d’altronde, è uno degli elementi principali dell’avventura), e sull’accostamento di «un mucchio di frammenti d’immagini private, sullo sfondo sgualcito delle stragi e delle incoronazioni».[6] Quella che scopre Antonino Paraggi, il protagonista del racconto, dunque, è una forma di rappresentazione che si basa, se vogliamo, sull’utilizzo di materiali di secondo grado, che vengono rifunzionalizzati attraverso il montaggio dotandosi, così, anche di una funzione sociale (o etico-politica), in grado di unire i destini individuali a quelli generali. La scoperta di Antonino, insomma, è quella dell’allegoria del Dramma barocco e dell’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica di Benjamin.
![fig. 1 Karina Puente, Zaira, da [In]visibles cities](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xTriscari_Zaira_g_fig1.jpg.pagespeed.ic.xvdh7GPBUR.jpg)