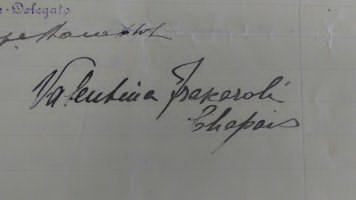Un crocevia perduto del nostro divenir donne si trova nel confondersi e nell’annullarsi delle nostre relazioni con la madre e nell’obbligo di sottometterci alle leggi dell’universo degli uomini.
Luce Irigaray, Il tempo della differenza
Nel panorama del cinema italiano contemporaneo l’opera di Alina Marazzi occupa un posto di rilievo sia per le scelte stilistiche che la contraddistinguono, innovative e sperimentali in un’area di intersezione tra cinema di finzione e cinema documentario, sia per l’attenzione a tematiche riconducibili a un’indagine sul femminile. In una inedita commistione di linguaggi eterogenei, attraverso l’uso di found footage, immagini d’archivio e di famiglia, ma anche interviste, animazione e così via, Marazzi compie un’operazione culturale di re-visione dell’immagine della Donna nella società italiana degli ultimi decenni indagando personaggi di donne reali che proprio perché «non aderiscono a modelli prestabiliti», vivono un forte senso di displacement e inadeguatezza nei confronti dei ruoli femminili tradizionali (Rich 1972). In quella che può essere definita la trilogia sulla maternità – che comprende Un’ora sola ti vorrei (2002), Vogliamo anche le rose (2007) e Tutto parla di te (2012) – la regista presta particolare attenzione al complesso legame madre-figlia, laddove la maternità è esplorata come una condizione problematica dell’identità femminile (Gamberi 2013). Afferma a questo proposito la regista: