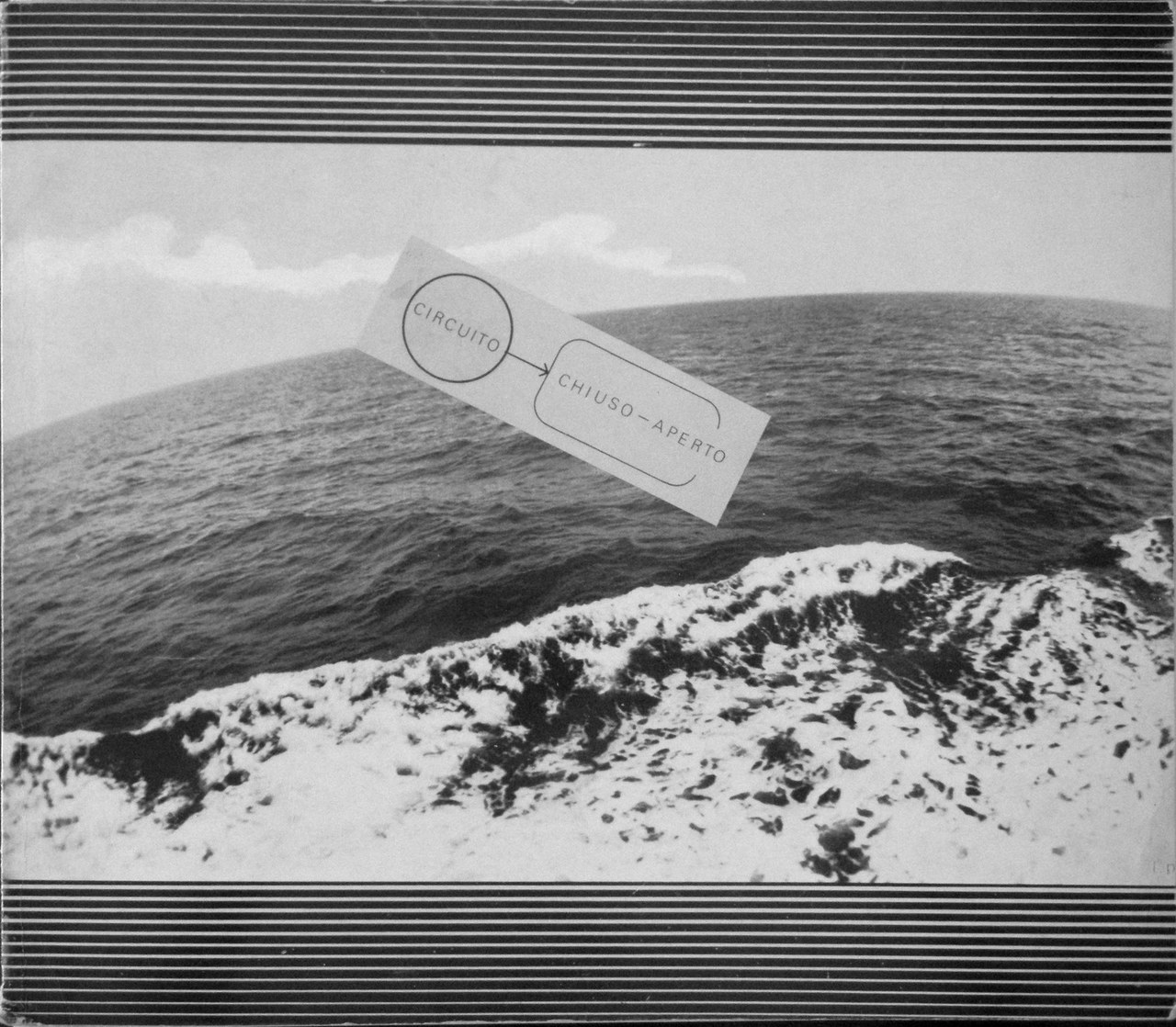A distanza di pochi anni dalla pubblicazione di Condominio Oltremare (L’orma, 2014), Giorgio Falco e Sabrina Ragucci tornano sulla via dell’incontro fra letteratura e fotografia, contribuendo a dare ulteriore impulso alle dinamiche verbo-visive messe in atto dalle produzioni fototestuali contemporanee. Flashover. Incendio a Venezia (Einaudi, 2020) è infatti l’ultima tappa – al momento – di un sodalizio che vede impegnati nella realizzazione di opere ibride e proteiformi uno scrittore la cui prosa mostra di possedere una spiccata propensione al visuale e una artista visiva che ha da poco scelto di dedicarsi, con il romanzo Il medesimo mondo (Bollati Boringhieri, 2020), alla scrittura letteraria. E di questa inscindibilità tra spazio narrativo e racconto fotografico, tra sguardi di natura diversa ma disposti a contaminarsi, Flashover sembra recare il segno già a partire dalla struttura del volume. Se si osserva la successione delle pagine, si nota che i frammenti iconografici, costituiti complessivamente da settantatre fotografie di Ragucci e da uno scatto eseguito da Falco (cfr. p. 52), sono intercalati nel testo privi di didascalie. L’esperienza di lettura che se ne ricava, pertanto, si nutre di un simultaneo integrarsi dei tasselli fotografici con l’impianto narrativo.
Riguardo innanzitutto alla componente verbale, il racconto appare racchiuso da una cornice che, nell’attacco e nei brani conclusivi, ricalca l’andamento descrittivo di una tradizionale terza persona romanzesca. Sul piano della forma, tuttavia, il testo di Falco sfugge alle definizioni. Non è «né romanzo, né saggio, né novella, né poesia» (p. 10) e – accordandosi, da questo punto di vista, a una più generale tendenza del romanzo contemporaneo ad accogliere documenti ‘grezzi’, linguaggi e generi del discorso non finzionali – concentra il funzionamento dell’ingranaggio narrativo sul recupero dei fatti. L’episodio di cronaca al quale l’opera si ispira è l’incendio del Teatro La Fenice appiccato nel gennaio del 1996 dal titolare di una ditta specializzata in impianti elettrici, Enrico Carella, con la complicità del cugino, nel tentativo di sottrarsi alla penale che la società avrebbe dovuto pagare per il ritardo accumulato rispetto alla fine prevista dei lavori. Riportando anche stralci delle deposizioni dei testimoni e degli imputati chiamati a processo quattro anni dopo l’accaduto, la voce narrante sviluppa in slow motion il racconto del gesto doloso e del modo in cui è stato premeditato, delle operazioni necessarie all’estinzione delle fiamme, della vita che in quegli istanti si consuma nella parte della città lagunare in cui si trova il teatro. Accanto a questo nucleo tematico, che procede come in studiata sintonia con l’imparzialità di un referto, si situano frequenti ‘smarginature’ della prosa, con l’effetto di una moltiplicazione dei livelli semantici. I passaggi divaganti rispetto al flusso diegetico sono di vario tipo. Numerosi sono i brani in cui, come a bilanciare il ritmo della narrazione, la voce narrante dialoga con se stessa – come quando, con un significativo slittamento dalla terza alla seconda persona, nelle pagine iniziali interviene e avverte: «(Da qui in avanti rinunci al romanzo […]. Rifiuti di assegnare profondità a ciò che profondo non è. Niente psicologismi, meglio abbandonare i personaggi alla solitudine dei propri gesti; […])» (pp. 9-10) – oppure anticipa gli eventi, secondo una più consueta funzione prolettica, oppure ancora esprime una dimensione universale liberata da condizionamenti di ordine sia spaziale che temporale: «(Compiamo sempre gli stessi gesti modulati attorno a piccolissime variazioni», si legge in una temporanea pausa dall’incendio, «ciononostante, crediamo ogni volta di fare qualcosa di nuovo; crediamo alle nostre menzogne, […] impreparati all’esito dei nostri gesti abitudinari; […])» (p. 69). Al di là degli esempi menzionati, evidenti sono anche le implicazioni metatestuali generate dalla progressione delle fasi dell’incendio: «(Ignizione, propagazione, incendio pienamente sviluppato, decadimento finale. Inizio, svolgimento, svelamento, conclusione. L’incipit è l’innesco, l’accelerante: […]. Quest’opera, invece, scaturisce dalla sequenza, dal montaggio. […])» (p. 38). All’interno di tale processo, il ‘flashover’ non solo rinvia alla fase di massima diffusione delle fiamme, al cosiddetto ‘incendio generalizzato’, ma diventa anche il punto di convergenza, testimoniato e accentuato dal titolo del volume, di una articolata risemantizzazione del termine in chiave metaletteraria.