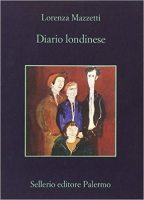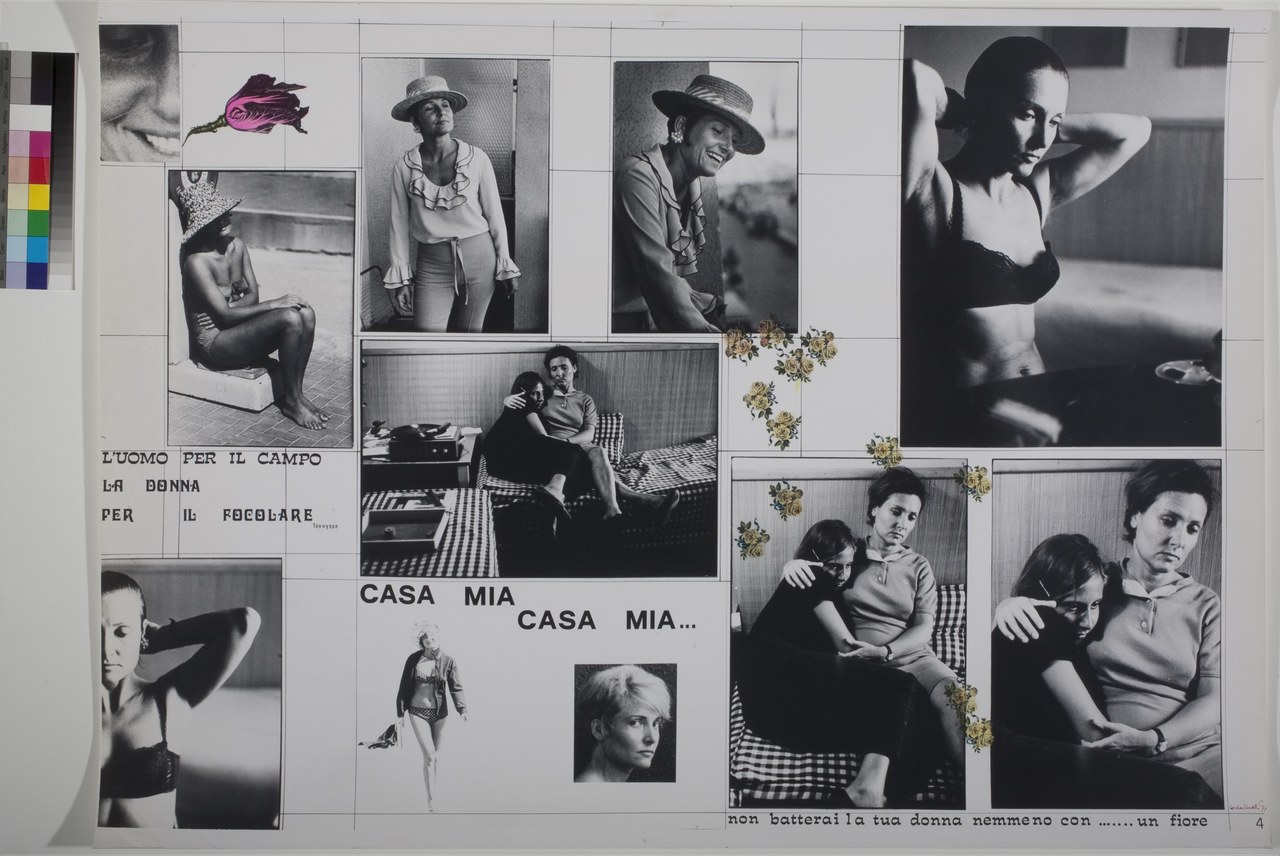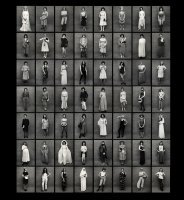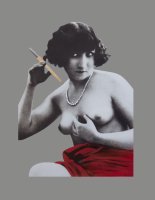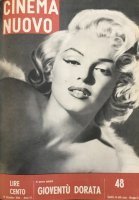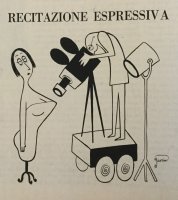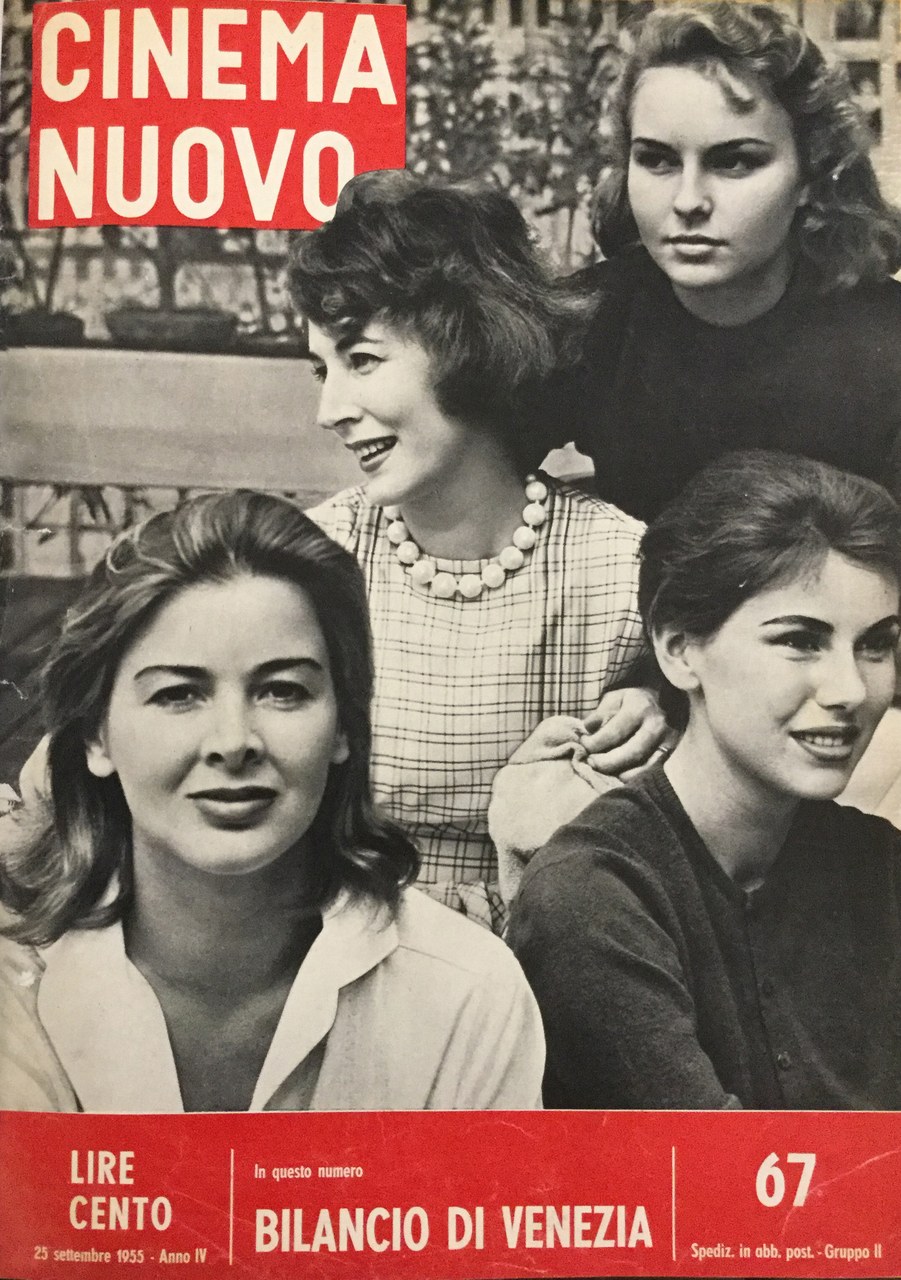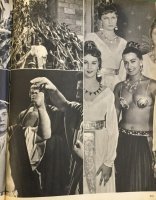La presenza di alcuni pittori indipendenti nello studio fotografico di Nadar nel 1874 a Parigi inaugura una nuova storia dello sguardo. In quella stessa occasione monsieur Manet presenta al Salon ufficiale La ferrovia, cercando più un dialogo con la tradizione che uno scontro accademico. Quest’opera tanto chiacchierata apre il saggio-racconto di Victor Stoichita, Effetto Sherlock (il Saggiatore, 2017).
Quello che il critico rumeno presenta nelle duecentoquarantatré pagine del suo ultimo lavoro è in parte suggerito dal sottotitolo all’edizione italiana: Occhi che osservano, occhi che spiano, occhi che indagano.
La copertina ospita un’enigmatica elaborazione grafica: una lente d’ingrandimento quasi sovrapposta a un’altra contiene il teleobiettivo del voyeur Jeff che dalla finestra sul cortile di Hitchcock (1954-55) è intento a spiare un ‘uomo alla finestra’, affacciato da una pittura di Caillebotte (1875). Questo incontro/scontro produce la sagoma di un terzo occhio che sembra spiarci, interrogare l’osservatore. L’invito dell’autore è chiaro: ci suggerisce di dare uno sguardo. Con stile impeccabile, con rigore logico e leggerezza immaginativa, Stoichita ci aiuta a indossare i panni dell’investigatore di immagini, accompagnandoci verso una storia dello sguardo da Manet a Hitchcock.
Nel quadro La ferrovia (1872-73) accade che non ci sia nessuna ferrovia. La cancellata nera elimina la possibilità della bambina (e la nostra) di scorgerne un solo frammento. L’opera sembra essere la cronaca di un oggetto fantasma che ci interroga sul possibile senso nascosto. Dialogando con la tradizione pittorica europea Stoichita trova nuove disquisizioni semantiche per indagare sull’accaduto. Profila sin da subito un leitmotiv che accompagna l’intero saggio: «lo sguardo ostacolato». Partendo dalla ferrovia di Manet, lo ritrova già nella pittura medievale, disegnando così, è il caso di dirlo, una strada ferrata che attraversa la tradizione del Seicento per giungere al cinema degli anni Sessanta. In questa lettura di viaggio, finestrini d’immagini della storia dell’arte e del cinema scorrono come paesaggi, sempre vari e contrastanti, accomunati dallo stesso tragitto semantico. Muovendosi dalle «figure-filtro» che nelle pitture impressioniste imitano la direzione dei nostri occhi, ostacolandola, Stoichita analizza un «sistema di filtri» (tende, umidità, alberi, e persone) che costringono a un continuo e frustrante «esercizio intellettuale della rivelazione». Il visibile non è più rassicurante: ostacolato perché opaco, singolare perché soggettivo, perde il punto di vista centrale e guarda da un’altra ‘prospettiva’.