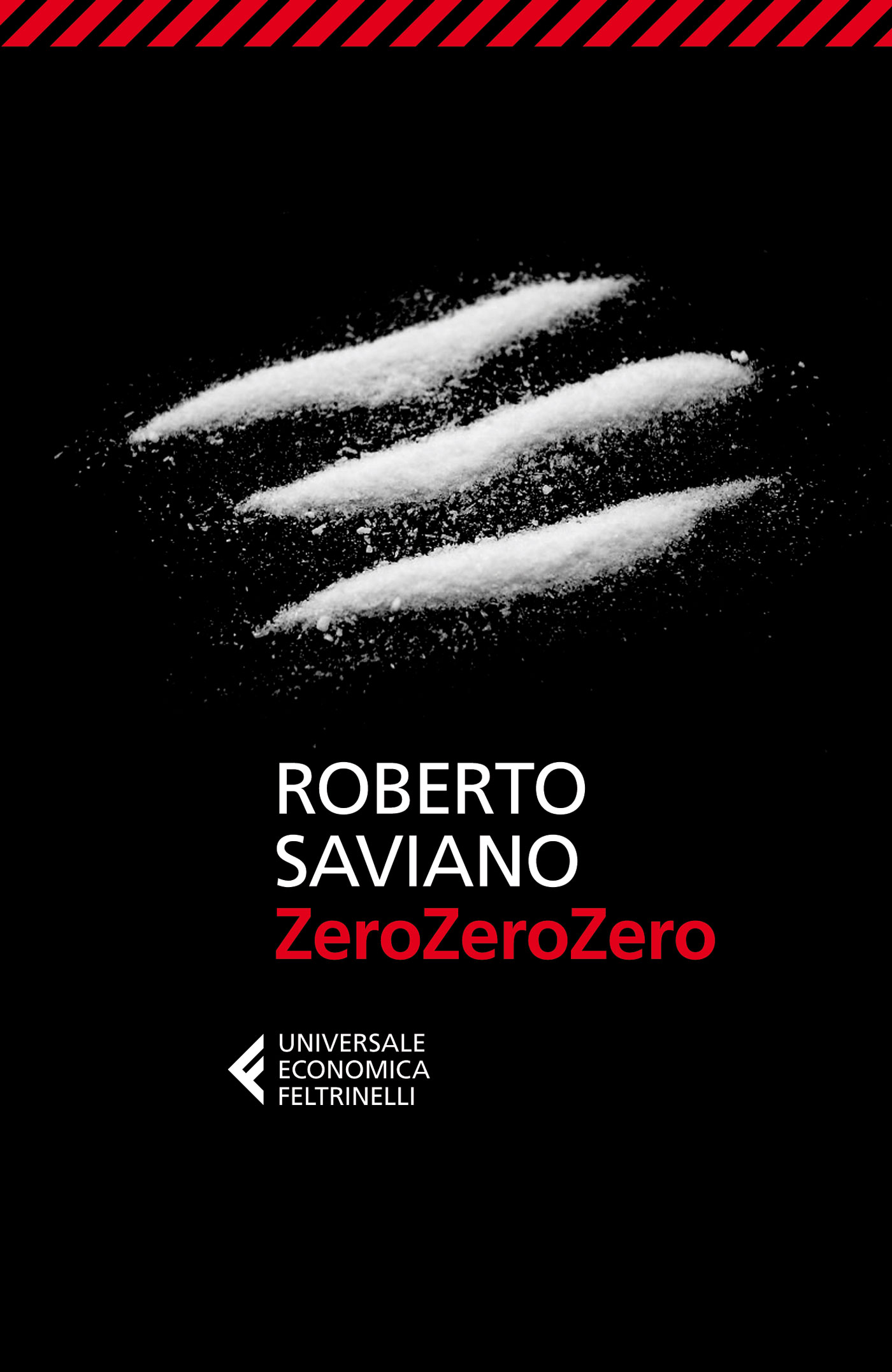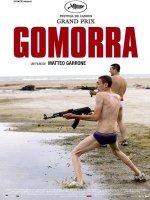La compagnia ravennate Fanny&Alexander è stata fondata nel 1992 da Luigi De Angelis e Chiara Lagani. Sin dagli esordi si è distinta per una rinnovata attenzione per il mondo della letteratura e delle arti visive, realizzando negli anni diverse produzioni: da spettacoli teatrali ad azioni performative e musicali, passando per installazioni e mostre, fino alla realizzazione di libri fotografici e opere video. Una «bottega d’arte» dove cooperano diverse personalità artistiche ‒ si pensi alla lunga collaborazione con il fotografo Enrico Fedrigoli, lo studioso Stefano Bartezzaghi e il collettivo Zapruderfilmmakersgroup. Tra questi figura anche l’attore Marco Cavalcoli che dal 1997 si è unito stabilmente alla compagnia.
Nel 1996 va in scena il primo spettacolo, scritto e ideato dagli stessi F&A, che attira l’attenzione del grande pubblico: Ponti in core. I protagonisti sono due ragazzi, Dorotea (Chiara Lagani) e Cipresso (Luigi De Angelis), che, accogliendo gli spettatori in un piccolo teatro anatomico, inscenano un susseguirsi di giochi macabri e funerei, in bilico tra l’innocenza e l’abiezione, la vita e la morte. È evidente come, sin dagli esordi, lo spazio e i dispositivi tecnologici che ‘orientano’ lo sguardo dello spettatore ‒ così come il tema del doppio ‒ si mostrino quali elementi cardini della poetica di Fanny&Alexander.
Le esperienze degli anni successivi, molto legate alla ricerca sul suono e sullo spazio, traghettano la compagnia verso la produzione del primo grande progetto dedicato alla messa in scena di un romanzo: Ada, tratto da Ada o l’ardore di Nabokov. Il progetto comprende sette spettacoli ‒ Ardis I (2003), Ardis II (2004), Adescamenti (2004), Aqua Marina (2005), Vaniada (2005), Lucinda Museum. Adieu por Elle (2005) e Promenada (2006) ‒ che esplorano l’opera-mondo di Nabokov secondo due traiettorie: quella dell’incesto e quella del rapporto tra spettatore e rappresentazione. Dalla deflagrazione dell’universo nabokoviano nascono anche altre ‘opere’ satelliti che completano il progetto Ada: la video installazione Rebus per Ada (Luca Sossella, 2007), realizzata insieme al collettivo Zapruderfilmmakersgroup e il foto-testo Ada. Romanzo teatrale per enigmi in sette dimore liberamente tratto da Vladimir Nabokov (Ubulibri 2006), che ripercorre, attraverso un’inedita drammaturgia verbo-visiva, il lavoro svolto dalla compagnia.