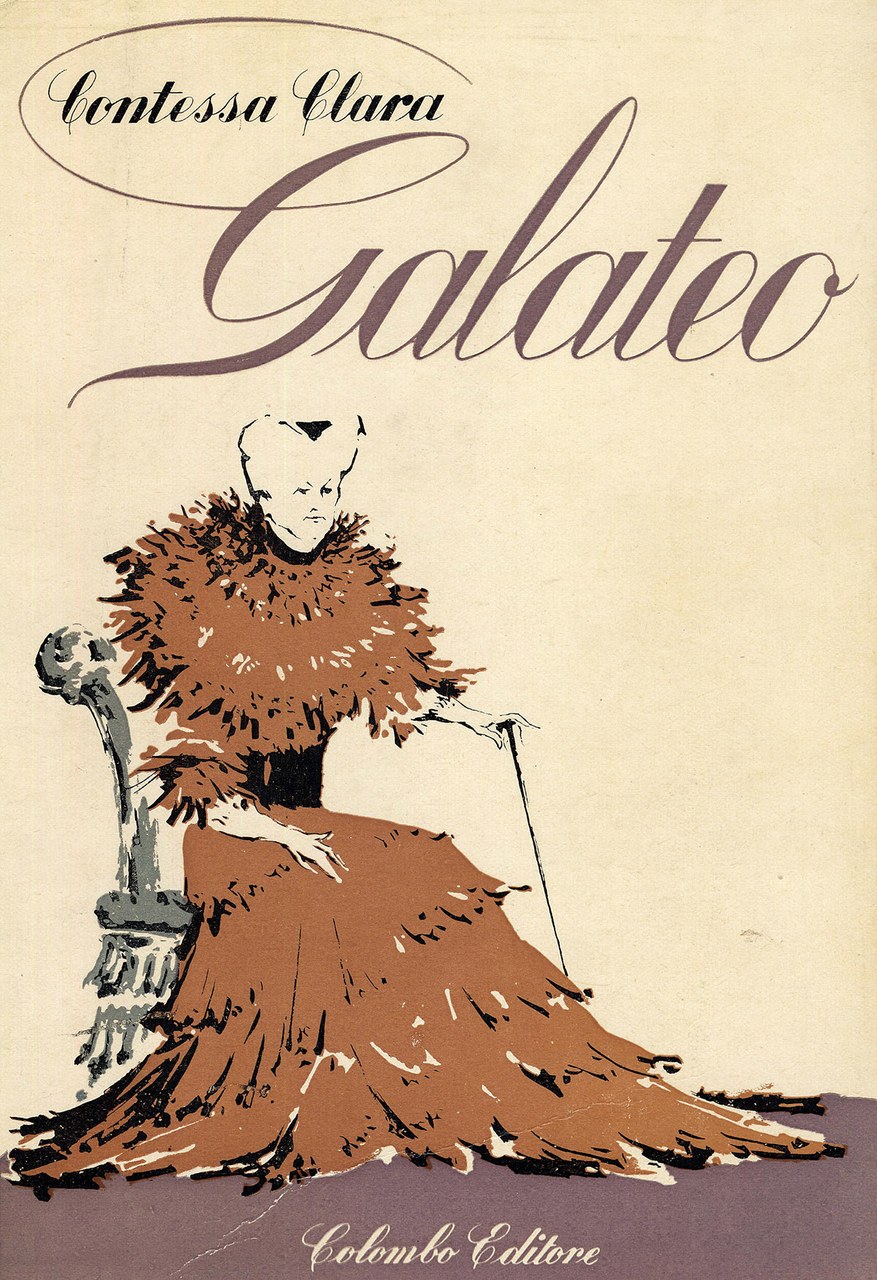1955. Tosca, Mafalda, Gina, Silvana, Loretta: le ragazze di San Frediano corrono intorno a Bob e, senza saperlo ancora, corrono verso il boom [fig. 1]. Quando, negli anni dei Pane e amore, la commedia si appresta a spostarsi in città, queste povere ma belle della Firenze popolare e corale di Pratolini, interpretate da Rossana Podestà, Giovanna Ralli, Marcella Mariani, Giulia Rubini e Luciana Liberati, con la loro esuberante vivacità anticipano nel lungometraggio d’esordio di Zurlini i ruoli di Marisa Allasio e di Alessandra Panaro, e inaugurano l’interesse del regista per le figure femminili. Se il film è Ê»dedicatoʼ al giovane rubacuori dalle presunte fattezze del divo hollywoodiano e agli altri Bob come lui, sono queste donne poco più che adolescenti, con i loro corpi snelli, i loro desideri confusi e l’unica certezza di voler conquistare l’amore di Andrea, a tessere un racconto che ne metterà piuttosto in luce le menzogne, i facili inganni, l’inettitudine. Ma nessun matrimonio allieterà il finale di questa unica commedia di Zurlini, che termina davanti a un treno e in una stazione, uno dei luoghi più cari al regista bolognese, segnato dall’impossibilità dei rapporti e dalla ineluttabilità del commiato: Bob non partirà con la facoltosa stilista e, forse, non lascerà mai il vicolo e la sua officina, mentre, forse ancora, una di quelle ragazze ha già preso in mano la valigia con la speranza di mutare il suo destino. Anche in Italia, intanto, sono arrivati i 45 giri, sta per arrivare il juke-box e i bar diventano un’altra cosa: Guendalina dell’omonimo film (1957) e i suoi amici ci passano i pomeriggi, e la spiaggia è ormai il luogo delle vacanze, delle canzoni e degli incontri. Zurlini avrebbe dato molto a questo suo ritratto di adolescente, che Ponti preferì invece affidare a Lattuada. Il Ê»noiʼ dei giovani di cui scrive Capussotti si declina qui in un conflitto che non è solo generazionale ma di classe, passando attraverso i corpi e il corpo, poi a lungo amato, di Jacqueline Sassard. Come le altre giovani straniere del cinema italiano del decennio a venire, Sassard vestirà ruoli inconsueti e ribelli in una modalità ritenuta meno offensiva rispetto a quelle norme patriarcali ormai troppo strette per le ragazze della Ê»prima generazioneʼ, indicando piuttosto nuovi modelli di indipendenza e libertà per le giovani spettatrici. Nel film che Zurlini riesce a girare soltanto cinque anni dopo, Sassard-Rossana è una delle ragazze di una comitiva in vacanza a Riccione. In quell’estate del ʼ43 che racconta Estate violenta (1959), primo capitolo della Ê»trilogia adriaticaʼ, e che era stata anche del regista, i giovani, scrive Morreale, somigliano a quelli degli anni Sessanta e di un filone balneare che proprio in quegli anni riprende vigore, ma il registro zurliniano è, come sempre e per sua stessa ammissione, disperato. Se Rossana, che vorrebbe le attenzioni di Carlo – un ventenne figlio di un gerarca che come i suoi amici è riuscito a tenersi a distanza da una guerra che qui sembra lontana, ma che non manca di apparire in tutta la sua violenza –, è una ragazza spigliata e di carattere che crede di sapere cosa significhi Ê»fumare una sigaretta in dueʼ [fig. 2], la Roberta di Eleonora Rossi Drago (una delle ex-ragazze di Miss Italia), vedova di una medaglia d’oro, madre di una bambina e figlia di una donna tirannica e austera (come non ricordare Perdutamente tua?), scopre per la prima volta nei suoi trent’anni la passione e l’amore. In questo melodramma borghese e d’autore, che intreccia il familiare e il materno, il bellico e il noir e che sembrerebbe privilegiare il protagonista maschile in un racconto di formazione dove, come accadrà nei film successivi, l’impossibilità dell’incontro tra i soggetti, condannati, come dice Canova, a non poter sperare, si misura sul piano dell’età e/o anche della classe sociale (La ragazza con la valigia, 1961) e dove la sfera privata non sfugge dal misurarsi con gli imperativi del sociale e della storia, è la figura sensuale e altera di Roberta ad acquistare un rilievo inatteso. Così la sequenza del ballo, un momento ricorrente e decisivo nella filmografia del regista, non è in realtà che il punto di implosione, sulle note di Temptation e poi di Mario Nascimbene, di un racconto di rumore e furore che ha inizio con gli esiti devastanti di una guerra osservata prima che vissuta, e che diviene elemento intrusivo e scatenante già nel corso del primo incontro sulla spiaggia. In questa storia tracciata dagli sguardi il paesaggio, San Marino e la progettata visita al Castello di Gradara che fu di Paolo e Francesca, è il teatro necessario alla messa in scena di un crescendo di emozioni leggibile sulla pelle. Un teatro scarno, deserto, vuoto come nelle inquadrature di Antonioni, a sottolineare lo spaesamento e la solitudine dei personaggi, ma che, come le marine ricorrenti nella trilogia, risuona della nostalgia di qualcosa di originario e di irrimediabilmente perduto. Qui gli occhi rivolti al cielo come nei film del maestro Rossellini non scoprono i miracoli delle stelle ma i bengala che illuminano la notte, pietrificando come in un incantesimo i giovani spettatori. E in questa ri-creazione di una relazione d’incanto, la notte, una notte che appartiene alla guerra e alla luna, si premura di nascondere e rivelare, affidando agli occhi di Roberta e al suo scambio di sguardi con Carlo che balla con Rossana [fig. 3], poi ai morbidi movimenti del suo corpo e delle sua braccia quando balla con lui, la regia del segmento che si conclude con l’atteso bacio in giardino sorpreso dall’arrivo della ragazza. Così la spiaggia deserta, divisa tra la notte e l’alba, diviene il luogo di incontri sempre più scandalosi e inaccettabili e Rossi Drago (già protagonista di Le amiche) può ricordare la Vitti di L’avventura con la sabbia tra i capelli [fig. 4]. Piste di sabbia, come le chiama Borri, a disegnare il percorso di Zurlini e del regista ferrarese, ma, nel caso del Nostro, esse riconducono al punto di partenza, a un ritorno spettrale che mai sarà così esplicito come nella Rimini di La prima notte di quiete (1972). Il 25 luglio manda per aria, insieme alla Casa del Fascio e alla carriera di Caremoli padre, l’inerzia vacanziera di Riccione e di un’intera classe sociale. La fuga in treno della coppia verso la villa di Rovigo e una presunta libertà naufraga sotto un rumore di bombe più violento del furore della passione. Se Roberta rinuncia al suo voler essere qualcos’altro oltre che madre [fig. 5], Carlo si avvia lungo i binari dell’incertezza, per raggiungere il Ê»brancoʼ o, futuro Dominici del terzo capitolo della trilogia, per starne fuori per sempre, straniero nella sua stessa casa, nella sua stessa terra. Addii.
Studiare il corpo (e i corpi) al cinema significa anzitutto considerare due distinte, sebbene interrelate, dimensioni. Da una parte, i film (e in generale i prodotti audiovisivi) rappresentano i corpi: li traducono, cioè, in immagini visive e sonore costruite attraverso molteplici forme di sguardo, caricandoli di significati di volta in volta differenti, e proiettandoli fuori dal mondo fisico e carnale e dentro un universo di fantasie, modelli e repertori immaginari. Dall’altra, i corpi sono anche (e soprattutto) una delle materie principali attraverso cui il cinema, la televisione e le arti elettroniche formano e sviluppano il loro discorso, la loro “parola audiovisiva”: pensiamo, ad esempio, a come i gesti e le voci degli attori e delle attrici partecipino alla produzione e alla messa in forma del racconto nel cinema narrativo, a come la performance corporea stia spesso alla base delle sperimentazioni videoartistiche; o ancora alla centralità assoluta del corpo (parlante, danzante, cantante, in ogni caso “presente”) che ha caratterizzato la comunicazione televisiva fin dalle sue origini.
Pensare il corpo negli scenari mediali obbliga a misurarsi con un oggetto visibilissimo ma intimamente sfuggente. Allo stesso tempo portatore e produttore di senso, il corpo cinematografico si impone come rappresentazione (e, dunque, come incarnazione di una pluralità di significati sociali, culturali, autoriali, e così via) e insieme come entità performativa, capace di creare significati attraverso la propria fisicità.