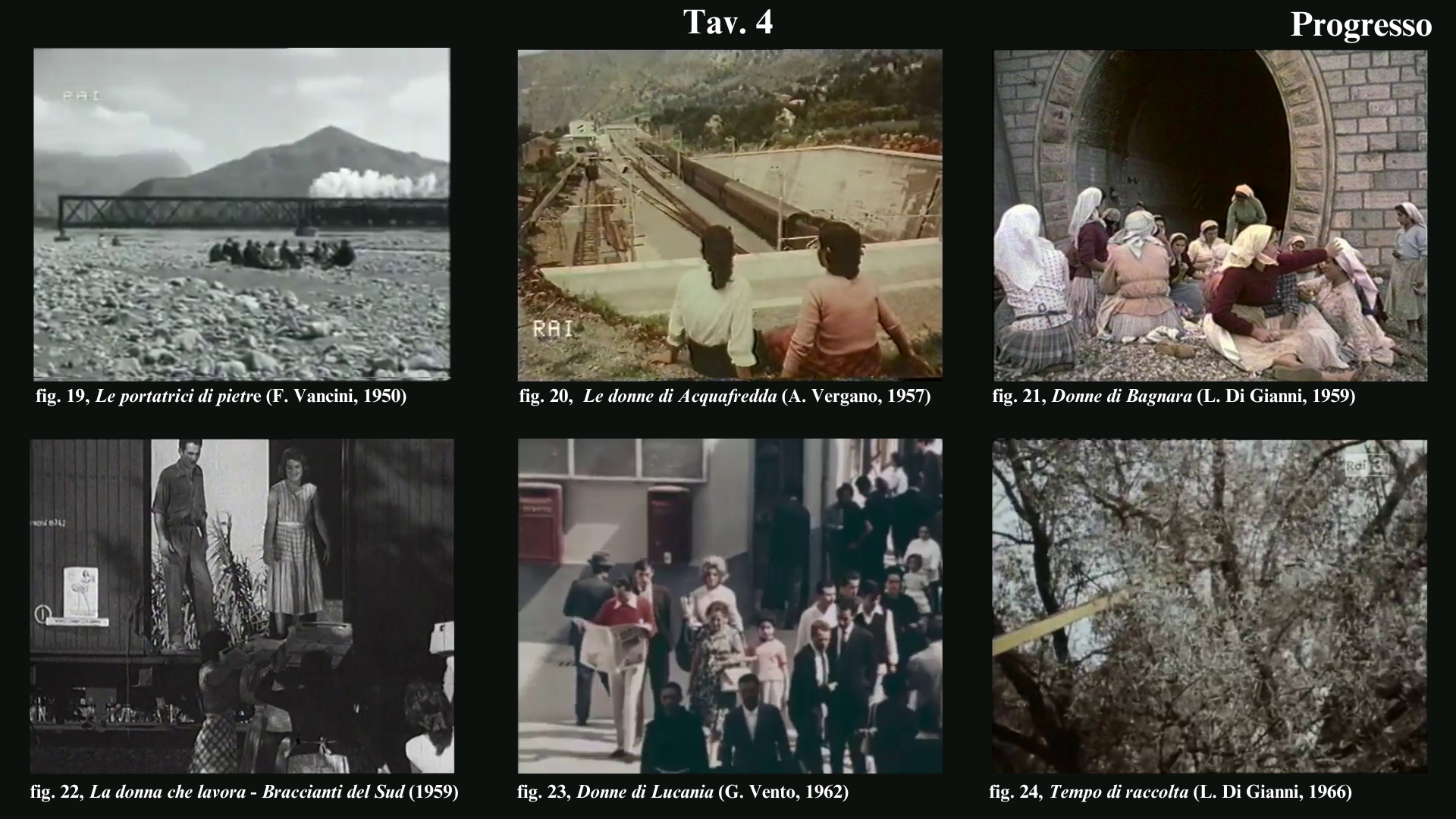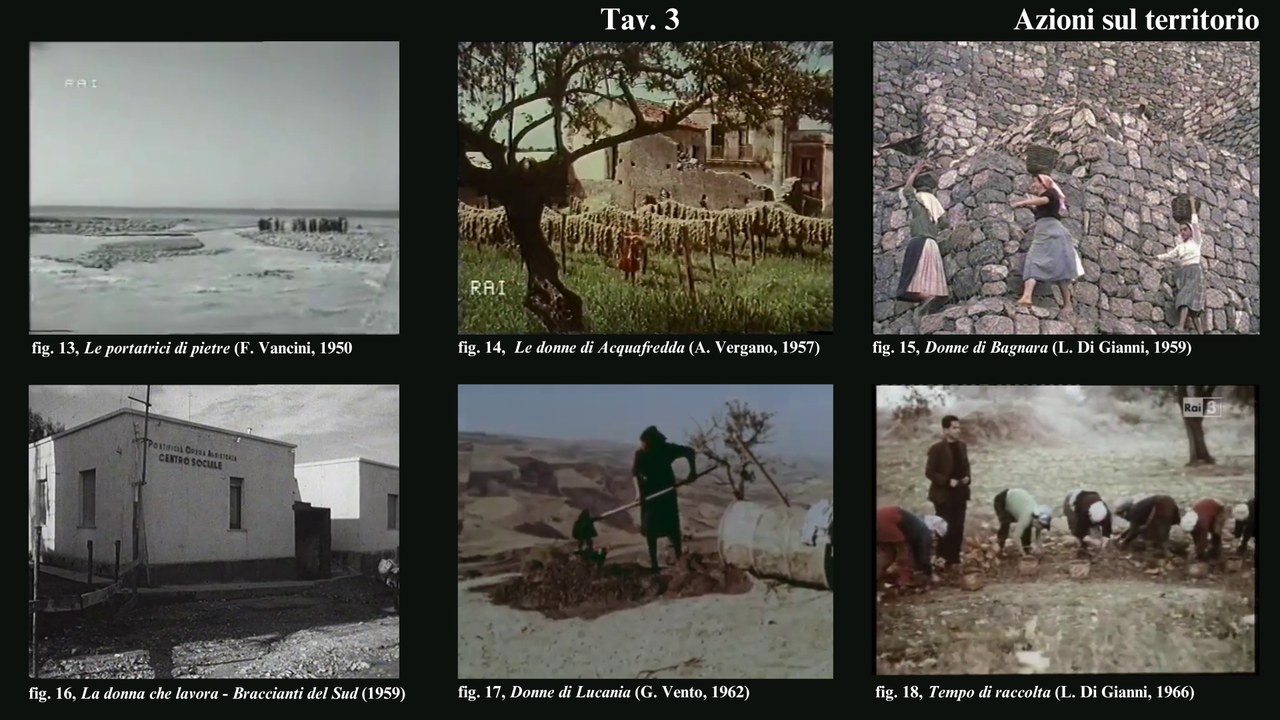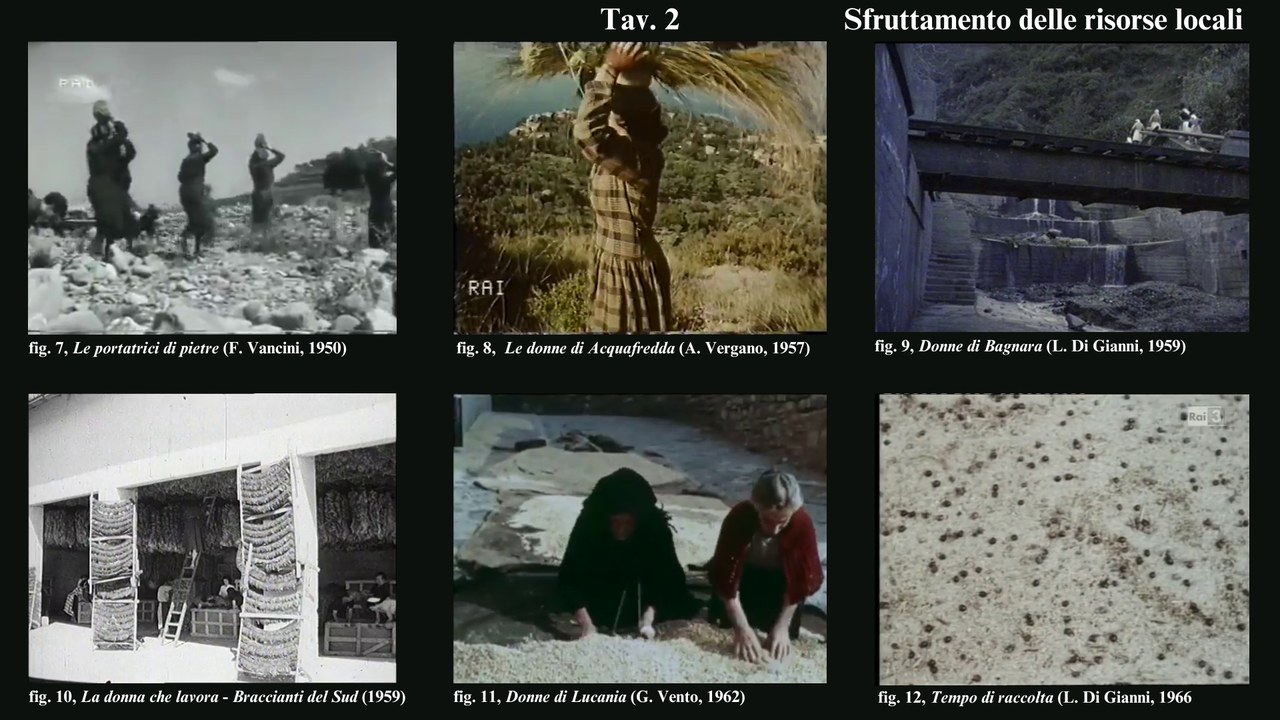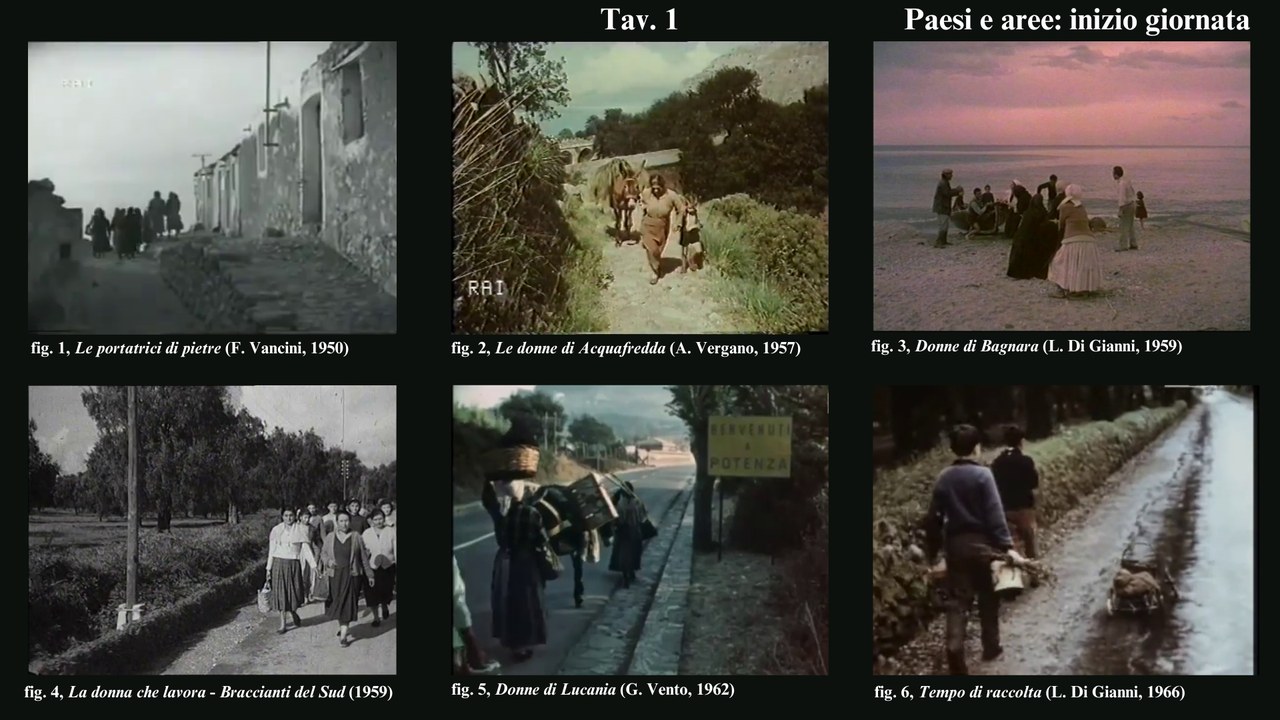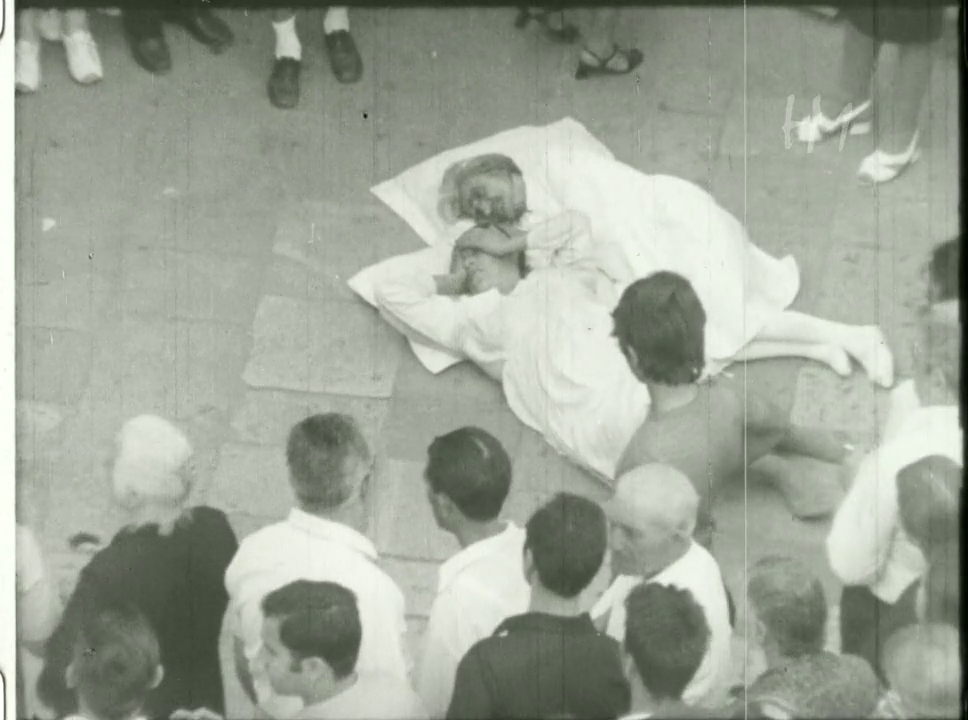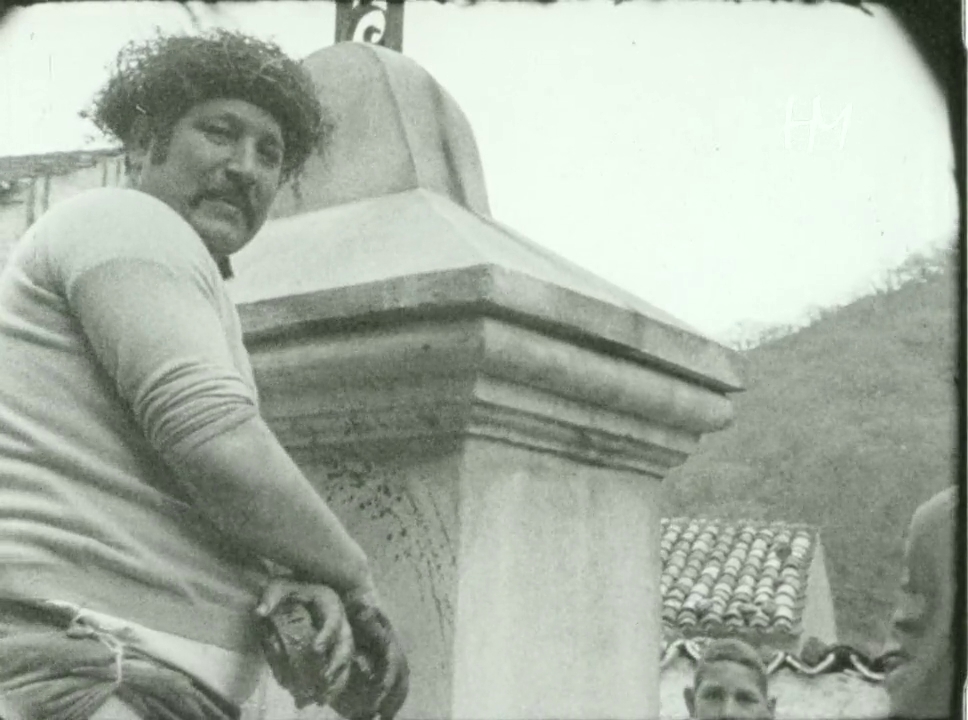La mostra curata da Giulia Carluccio per Galleria Campari, Red carpet: il cinema dei sogni. Campari e l’immaginario del divismo 1900-1960 indaga il fenomeno del divismo cinematografico sotto la lente delle rifrazioni pubblicitarie, dell’infra-mondo dei processi culturali e comunicativi legati ai brand e alle politiche di spettacolarizzazione dei prodotti commerciali. Si tratta di un campo largo, attraversato da pulsioni consumistiche e proiezioni identitarie, che emerge già nei primi anni del Novecento e si distende poi lungo tutto il secolo, attivando via via pratiche artistiche e produttive sempre diverse.
L’idea chiave su cui si concentra Carluccio, grazie alla committenza Campari e alla disponibilità di materiali di grande interesse presenti in archivio,[1] riguarda l’osservazione di alcuni aspetti del divismo, vera e propria mitologia moderna che «vive di immagini e narrazioni che prendono forma sullo schermo, ma sostanziano e prolungano la loro esistenza intorno e oltre la proiezione».[2] I volti enfatici del muto, il corpo metamorfico di Chaplin, la silhouette di Garbo sono i primi indizi di un processo di profonda trasformazione dei consumi e delle velleità comportamentali di spettatori e spettatrici, coinvolti in ritmi di visione e idealizzazione tali da generare nuove forme di contatto con le ombre del cinematografo. L’industria culturale del Novecento si popola, per effetto dei sogni di celluloide, di oggetti ‘magici’ ed evanescenti (i cosiddetti ephemera),[3] che amplificano e riverberano l’aura di attori e attrici aggiungendosi al volume di cartoline, manifesti, brochure e riviste che ne esaltano la star persona; su un altro piano, quegli stessi «semi-dei»[4] alimentano i codici espressivi della moda e della pubblicità, in un intreccio virtuoso di pose e modelli. Si assiste così alla progressiva affermazione dei divi come protagonisti della comunicazione, fenomeno che presto interessa alcuni marchi aziendali, pronti a contribuire all’invenzione del nuovo alfabeto delle stelle.[5]