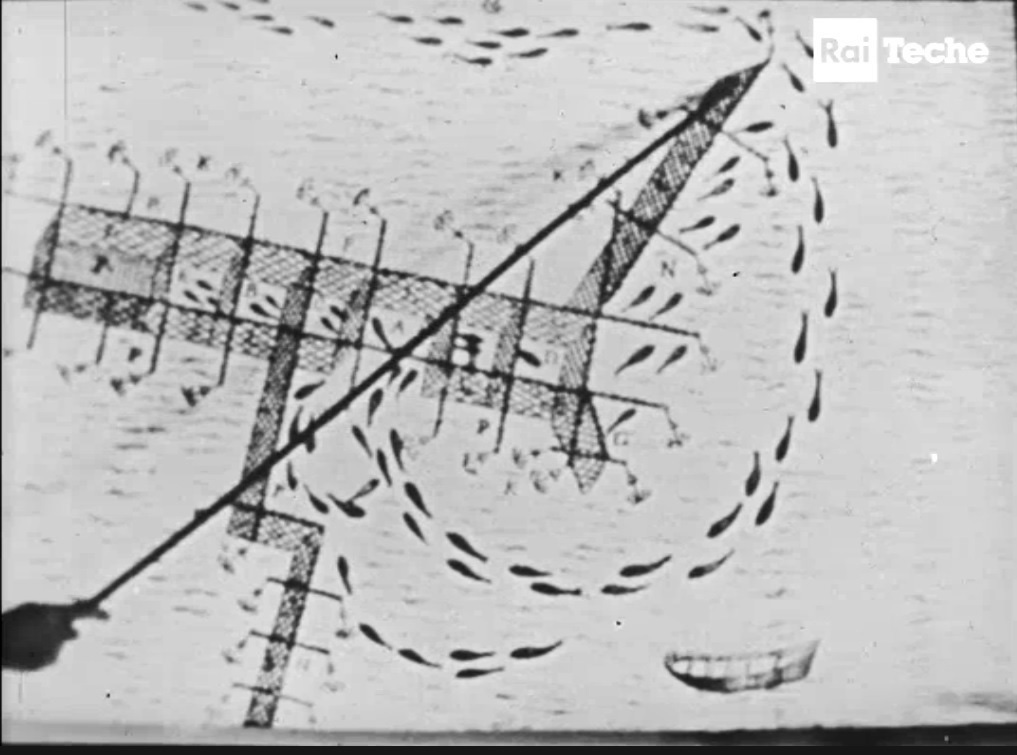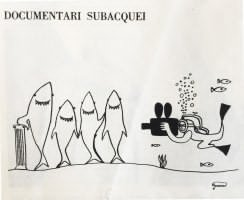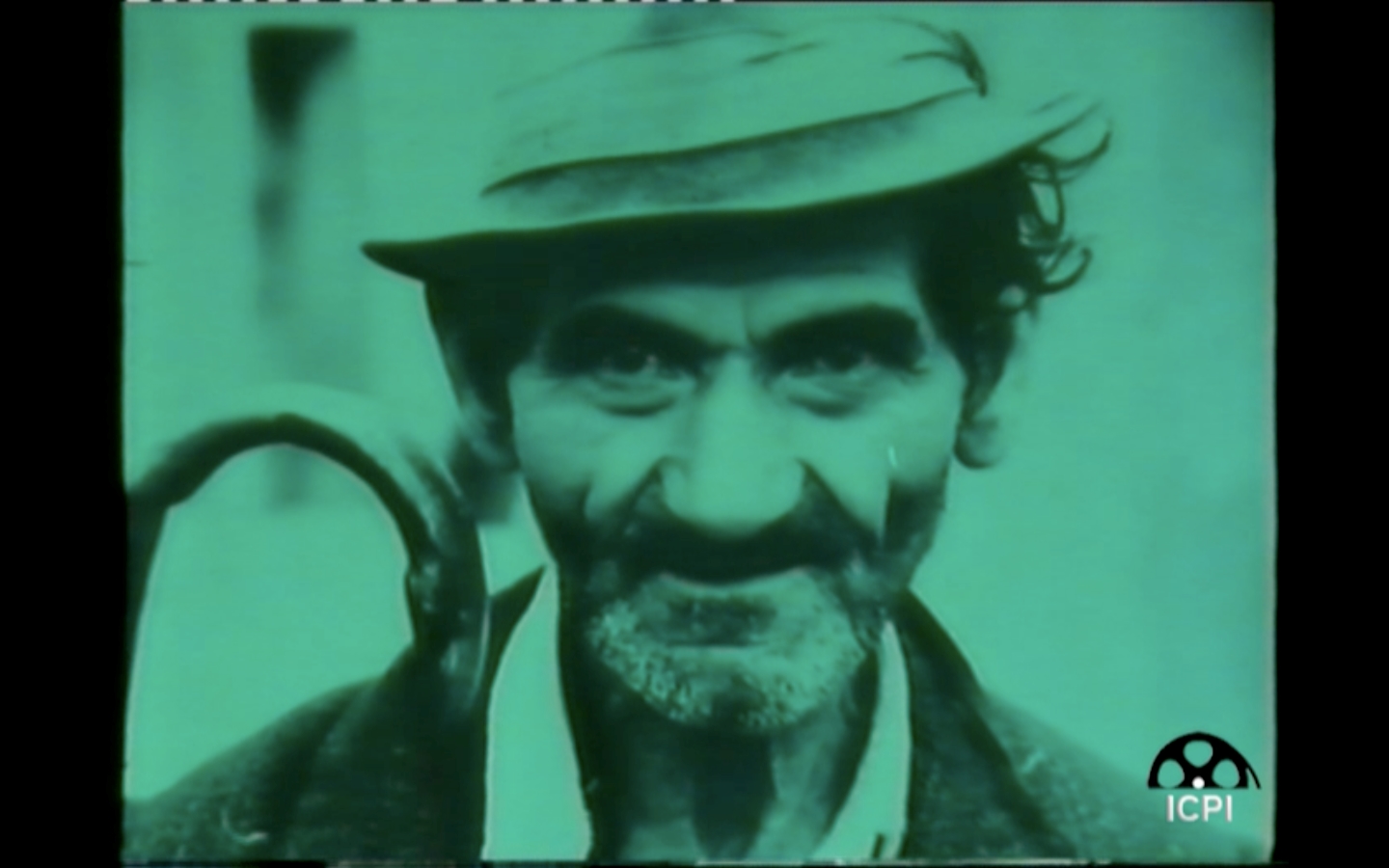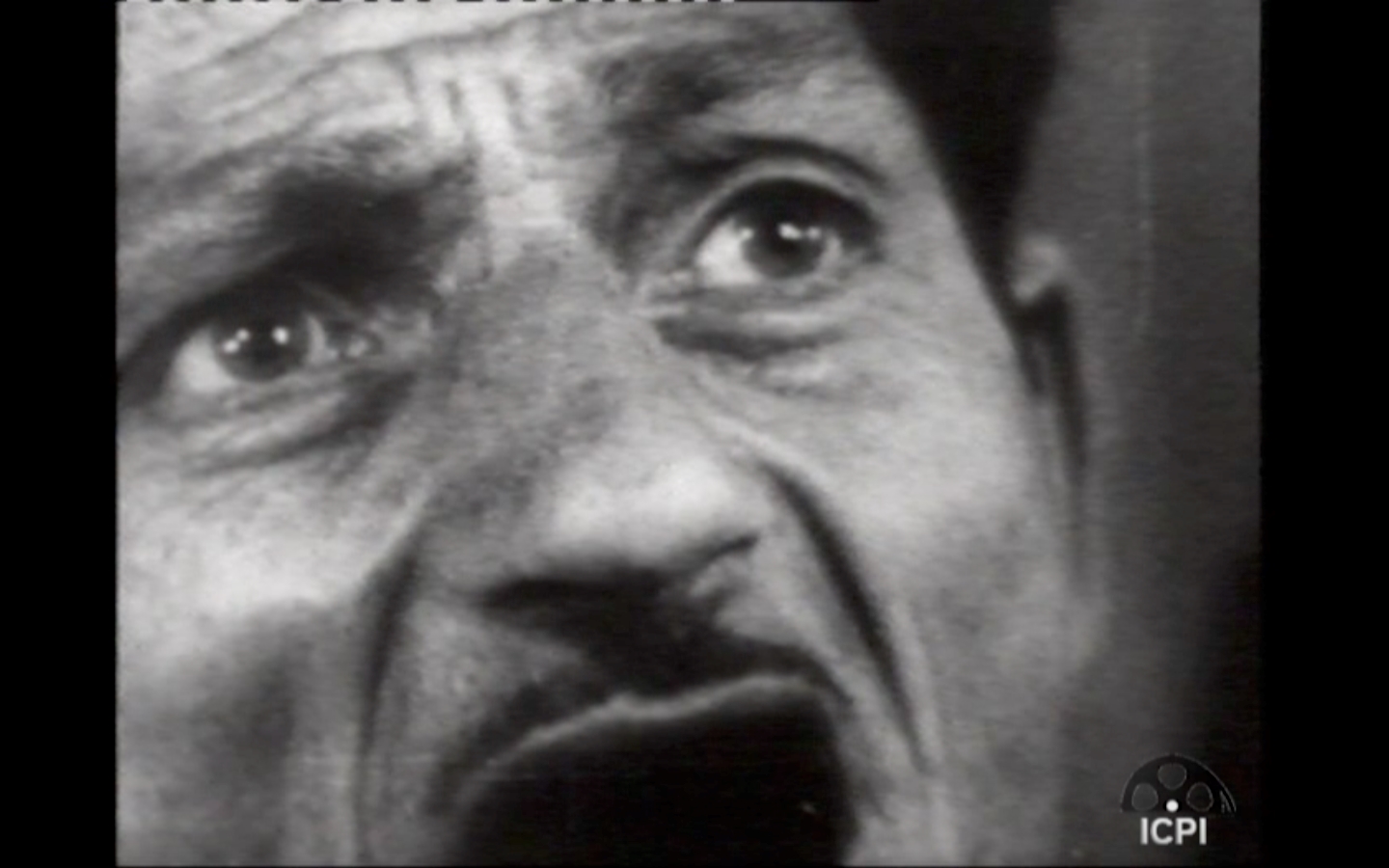Una volta a Messina c’era una madre che aveva
un figlio a nome Cola che se ne stava a bagno
nel mare mattina e sera.
La madre a chiamarlo dalla riva: «Cola! Cola!
Vieni a terra, che fai? Non sei mica un pesce?»
E lui a nuotare sempre più lontano.
Italo Calvino, Cola Pesce
Sul soffitto a volta del Teatro di Messina Vittorio Emanuele II è raffigurata una scena tratta dalla leggenda di Cola Pesce (o Colapesce), il giovane ragazzo ‘mezzo uomo e mezzo pesce’ che venne mandato dal Re a vedere cosa si nascondeva lì dove il mare era più profondo. Dopo aver nuotato attorno alla Sicilia, Cola disse al Re che Messina poggiava su tre colonne, una delle quali, erosa dal fuoco dell’Etna, era in procinto di cedere. Diverse sono le versioni della leggenda, ma tutte hanno un tragico epilogo: Colapesce si immerge un’ultima volta – per recuperare la corona del Re o, nella versione più celebre, per sorreggere la colonna che sta per cedere sotto il peso della città – e non fa più ritorno in superficie.
Commissionato nel 1985 dall’allora consulente del teatro Gioacchino Lanza Tomasi, il maestoso affresco è una delle ultime – nonché più grandi – opere realizzate da Renato Guttuso, e mostra il giovane Cola, attorniato dalle sirene, ritratto nell’attimo che precede la sua immersione nelle acque dello Stretto, a rappresentare il rapporto simbiotico che intercorre tra la Sicilia e il suo mare.