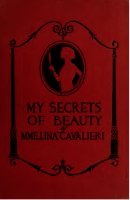1. Donne che traducono
Siamo nei primi anni Novanta e a scrivere alcuni appunti riguardanti la traduzione della serie di novellizzazioni La signora in giallo (romanzi basati sulla serie televisiva di Peter S. Fischer, Richard Levinson e William Link) è Lisa Morpurgo. Le parole di questa professionista dell’ambito editoriale possono tuttavia considerarsi rappresentative delle operazioni di moltissime altre figure femminili che intraprendono l’attività traduttoria: un impiego che, ‘consentito’ alle donne in quanto esercitabile anche da casa e, soprattutto, ritenuto di secondaria importanza rispetto alle scritture degli autori, permette loro di uscire dalla propria sfera privata e di esprimersi pubblicamente tra le righe. In quanto alla ‘femminilizzazione’ del lavoro di traduzione in Italia non vi sono attualmente dati sistematici, essendo le indagini dedicate all’argomento proliferate nell’ambito degli studi sull’editoria soltanto di recente, in particolare sulla scia dei Traslation Studies (si veda per esempio Venuti 2005, Cunico e Munday 2007), e focalizzandosi i contributi prevalentemente sulle mediatrici culturali più rinomate (Finocchi e Marchetti 1997, Brigatti et al 2018).
Un termine a quo dell’ipotetico processo di regendering che investe il settore nel Paese e che giunge fino a oggi è stato ciononostante pressoché stabilito. Già tra il XIX e il XX secolo numerose intellettuali italiane intraprendono invero la professione di traduttrici, ma è verosimilmente negli anni Trenta che le donne conseguono, all’interno di un ramo decisamente nascosto della nascente industria editoriale, «uno spazio» più «squisitamente femminile»:

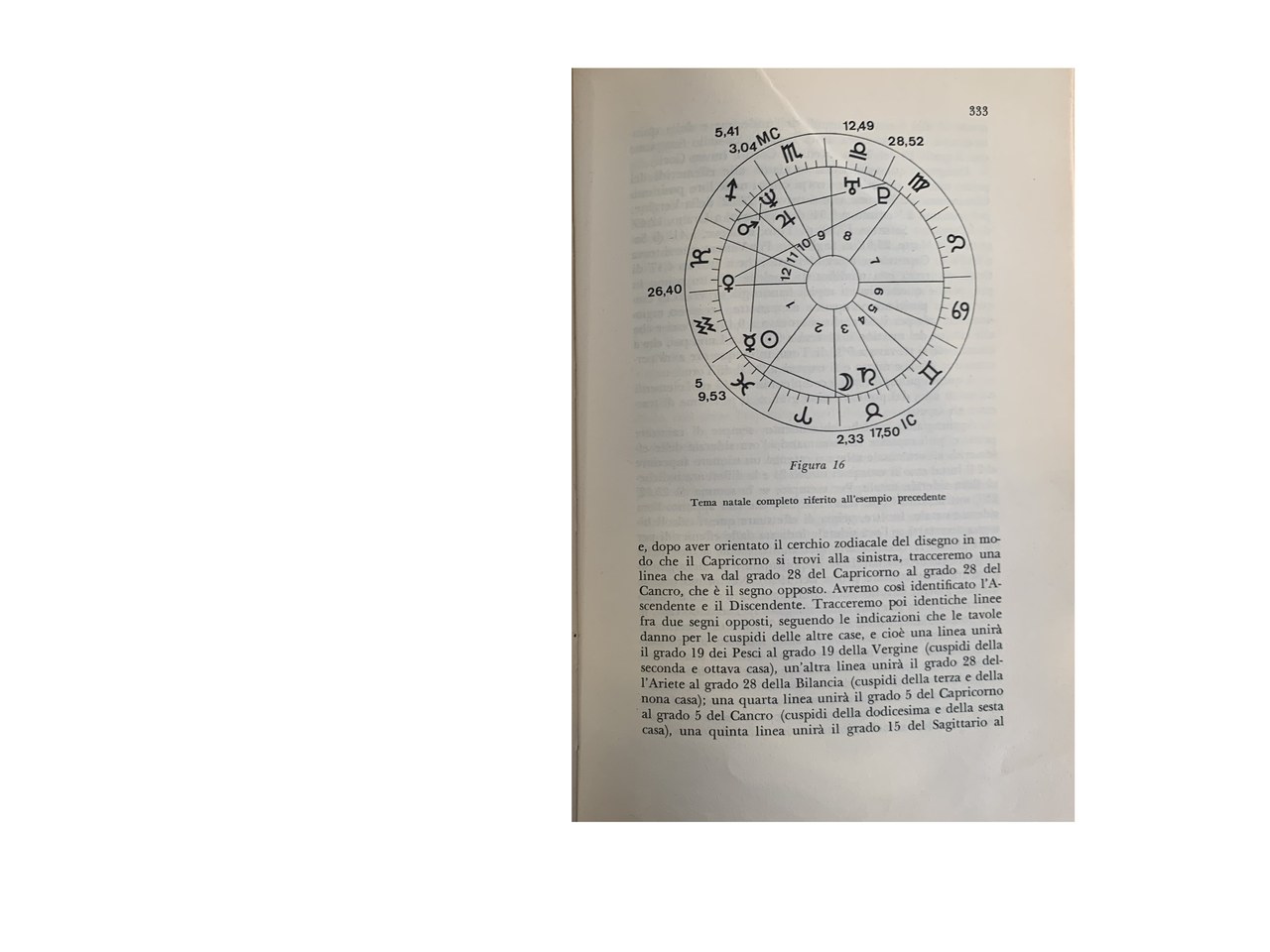



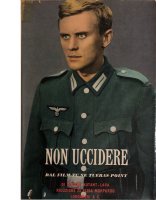



















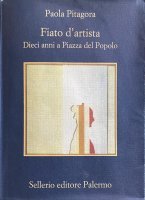


![Fig. 2 Anna Fougez in “Fiore selvaggio” (1921, di Gustavo Serena) [fonte: https://www.ilcinemamuto.it/betatest/omaggio-ad-anna-fougez/]](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xmosconi_g_fig2.jpg.pagespeed.ic.s4kvHaCGn7.jpg)