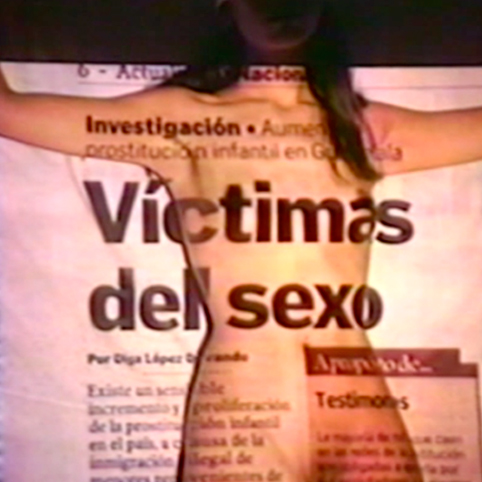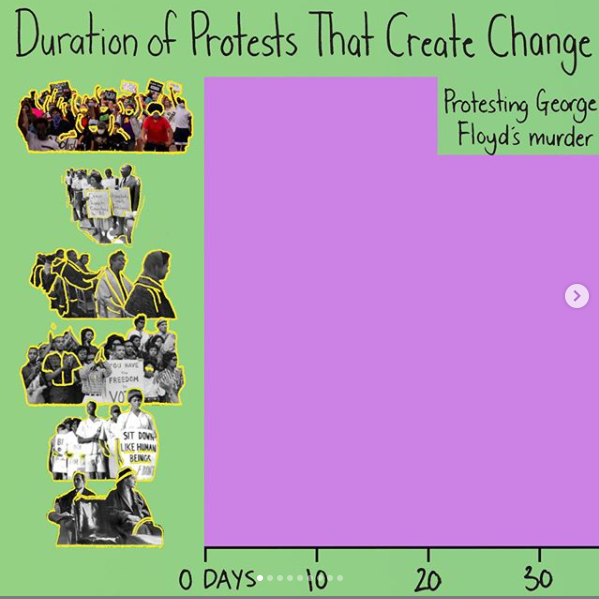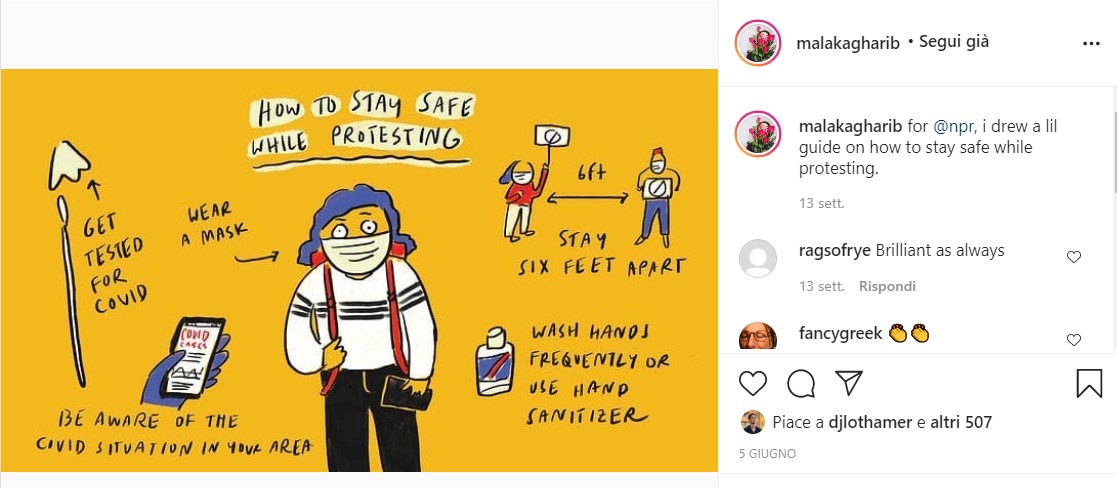1. Pellicole. Fotografie e film
Scomparsa per suo volere nel 1981, a ventidue anni, Francesca Woodman si delinea ormai come figura centrale dell’arte visiva contemporanea, in un caso notevole di celebrità sorta e come esplosa poco tempo dopo – e forse a causa – di quella morte precoce e drammatica. In effetti, a partire dalla prima esposizione postuma nel 1986, negli anni a seguire sono state proposte numerose retrospettive delle sue opere, tra le quali una monografica di più di centoventi scatti al Guggenheim di New York nel 2012; e sono apparsi poi svariati saggi e monografie,[1] fino a fare di Woodman un nome molto noto e ricorrente anche negli ambienti meno specializzati, in una dinamica non lontana da quella che ha dato forma alla leggenda di Vivian Maier in anni ancora più recenti.[2]
Il documentario sperimentale della regista statunitense Elisabeth Subrin, The Fancy (2000), ripercorre la vicenda biografica di Woodman in una dimensione per molti aspetti inusuale, giacché gli scatti dell’artista non sono mostrati ma rievocati in descrizioni affidate a una voce over e performati da modelle che ne replicano le pose, così da costruire una sorta di ritratto in absentia dai toni suggestivi e talvolta inquietanti.[3]
Dal canto suo, il film di Scott Willis The Woodmans, presentato al Festival di Roma nel 2010 e dalla struttura più convenzionale, è dedicato al ricordo della fotografa in una sorta di album di memorie raccolte dai familiari e da chi le è stato vicino, come indica il titolo, in una polifonia di voci e immagini che accosta interviste, fotografie di famiglia, pagine di diario a filmati e immagini prodotti dalla stessa Francesca.[4]