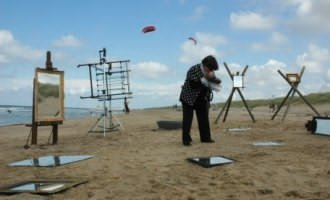Danzatore di formazione classica, ha fondato nel 1989 la Compagnia Zappalà Danza, sostenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sin dal 1996 e indubbiamente tra le realtà europee più interessanti per quanto concerne il panorama della danza contemporanea. Un percorso di oltre trenta produzioni che attraversano le tematiche più varie, mantenendo sempre una spiccata attenzione verso il sociale e verso ciò che si muove intorno all’occhio vigile e attento dell’artista. Le sue coreografie nascono spesso seguendo una progettualità più ampia, all’interno della quale Zappalà traccia una vera e propria mappatura a tappe, a ‘pre-testi’ che sfoceranno dopo in una danza totale.
Significativa, in tal senso, la collaborazione oramai di lunghissima data con Nellò Calabrò, il quale si occupa dell’aspetto drammaturgico, letterario e verbale degli spettacoli. Innumerevoli le collaborazioni e le creazioni per altre compagnie ed enti artistici di rilievo come il Balletto di Toscana, la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, il Norrdans e il Goteborg Ballet.
A partire dal 2002, e ancora più dal 2003, Roberto Zappalà è riuscito a fondare una vera e propria ‘casa’ della perfomance, Scenario Pubblico, tempio di ricerca sul corpo unico in Sicilia e luogo ove regolarmente vengono formati nuovi danzatori mediante un progetto di approfondimento del linguaggio coreografico della Compagnia Zappalà Danza.