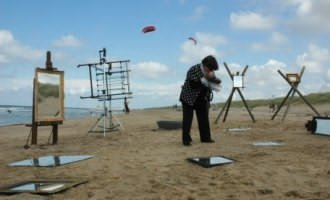«Welcome to Battersea Power Station»: questo messaggio di benvenuto, reso effervescente dal dinamico sfondo di sequenze video in cui tutti sorridono, inebriati da cibo e bevande, musica, yoga e shopping, accoglie l’internauta che si appresta a fare una ricerca sulla omonima centrale elettrica londinese.
Nell’homepage del suo sito si celebra, infatti, l’apertura di una delle «London’s most exciting new shopping and leisure destinations», frutto della riconversione della centrale a carbone di Battersea, dal 1980 inserita nella National Heritage List come Grade II* Building a ragione del suo interesse architettonico e storico.[1]
Bisogna addentrarsi nella piattaforma web per scovare qualche cenno alla storia dell’edificio, che si apprende essere opera di Sir Giles Gilbert Scott, famoso architetto attivo agli inizi del secolo scorso, noto soprattutto per avere progettato le cabine telefoniche rosse, uno dei simboli dell'Inghilterra: scarni sono i riferimenti alle qualità strutturali e agli elementi in stile Art Deco, e solo una sintetica timeline riassume i principali eventi, dal 1929, con l’inizio dei lavori, al 1983, anno della cessazione dell’attività, e poi ancora fino al 2012, quando avviene l’acquisto da parte degli attuali shareholders. Questi ultimi, evidentemente, preferiscono gli slogan a una contestualizzazione, seppur sommaria, della centrale e delle sue attività nelle vicende socioeconomiche e culturali del paese:
Anche sul sito di WilkinsonEyre, lo studio di architetti che ne ha progettato e curato il restauro e la riconversione, la storia della centrale è limitata a sei righe, tre delle quali dedicate a ricordare, come un glorioso aneddoto, l’apparizione dell’edificio sulla copertina dell’album dei Pink Floyd Animals, uscito nel 1977. Questo cenno, con tutta probabilità inserito con l’intento di accrescere il prestigio del complesso, fornisce a chiunque abbia in mente quel disco e, soprattutto, quell’immagine, un indizio che rimanda a un’altra storia, assai più amara e cupa di quella di un’innocua e prodiga centrale elettrica che ha permesso alle generazioni passate di «mangiare, bere, comprare e giocare».