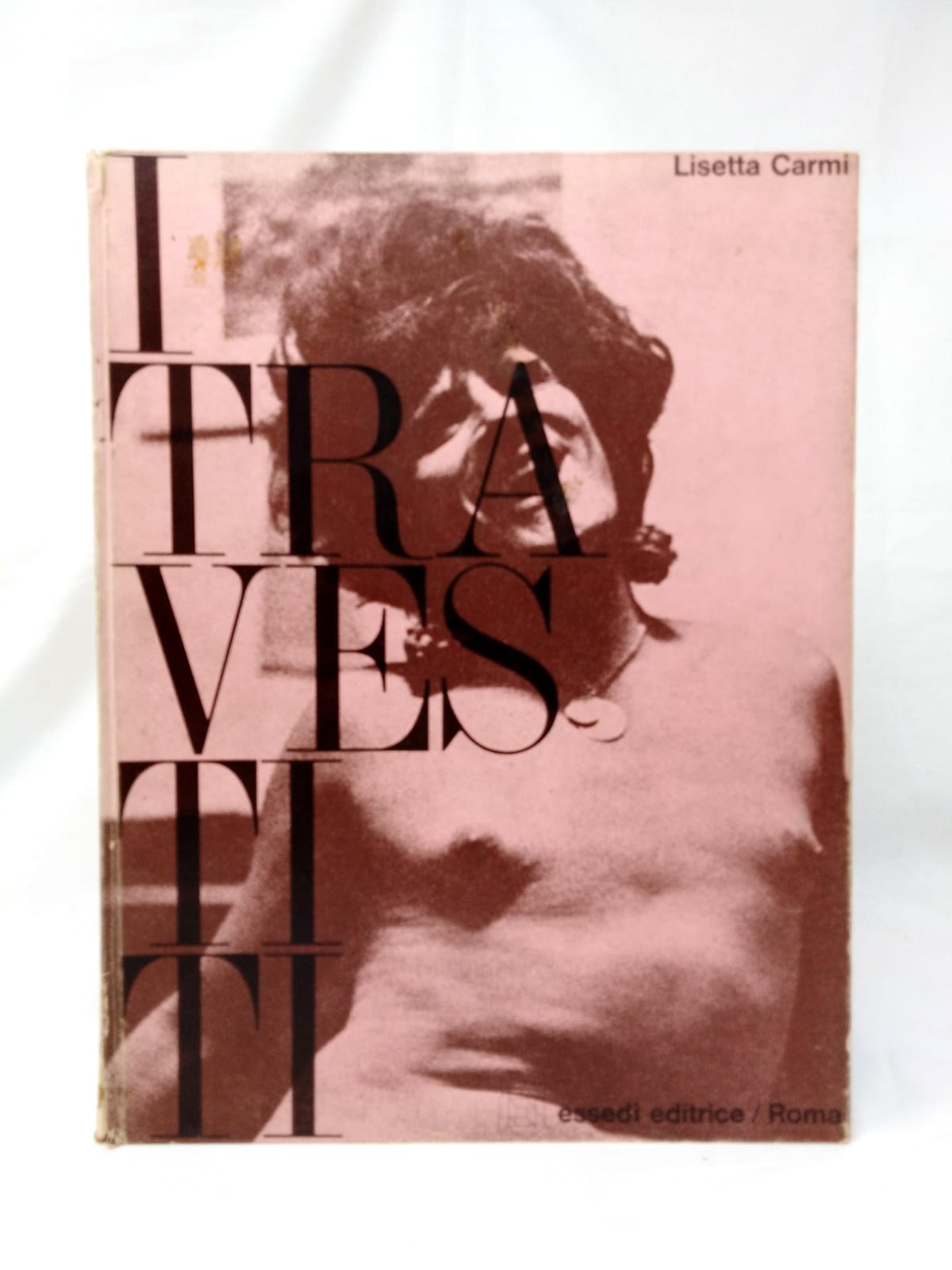Parrebbe databile all’ultimo decennio un’attenzione finalmente costante a un fenomeno invece assai più di lunga durata qual è il fototesto, sia in quanto oggetto di studio che come definizione, e più annosa la cosa che la parola, se è vero che la prima risale a Georges Rodenbach, Bruges-la-morte (1892), e la seconda a Wright Morris, The Inhabitants (1974). Più di ottant’anni. Il fatto è che per la resistenza teorica diffusa verso gli oggetti ibridi e non classificabili, si è dovuto attendere che il fototesto venisse derubricato da genere letterario a oggetto nella gamma dei mixed media.
Ora il fototesto riceve in Italia una sistemazione teorica in questo volume di Giuseppe Carrara, Storie a vista. Retorica e poetiche del fototesto (Mimesis, 2020), destinato a essere maneggiato a lungo dagli studiosi e dagli studenti, per la completezza e l’apertura dell’informazione sulle teorie, per l’originalità con cui affronta i nodi e propone (provvisorie) soluzioni e definizioni (la ‘retorica’ del sottotitolo), ma pensiamo soprattutto per l’efficacia con cui le teorie e i metodi servono alla lettura di testi disparati (le ‘poetiche’), con l’ambizione di designare un canone del fototesto ma più efficacemente – riconosce infine lo stesso autore – di tracciare percorsi. E testi si dice qui per comodità, non intendendo un ‘enunciato scritto’, perché deve abbandonarsi ormai l’idea gerarchica per cui l’immagine debba servire alla parola. Ed è anzi questo, poi, il dubbio: funzionerebbero i fototesti anche senza immagini? Come mai la parola letteraria ha bisogno delle immagini? Non ha più nel mondo in cui viviamo l’energia di produrre autonomamente immagini (le images, le immagini immateriali che si formano nella mente del lettore, di cui parla W.J.T. Mitchell), che sarebbe poi il mestiere della letteratura?