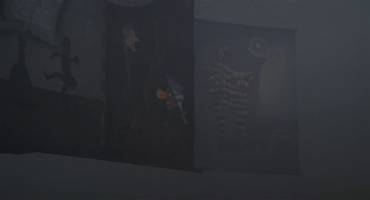Per Lucrezio le immagini sono «simulacri dei corpi che qua, che là van volando, quasi membrane staccatesi dal loro involucro esterno, per l’aria». Con questa citazione dal De rerum natura Giuliana Bruno apre il saggio intitolato Superfici, (Johan & Levi, 2016) e partendo da questo assunto si interroga sulla natura delle immagini, rileggendole a partire da ciò che dà loro consistenza: la superficie.
La studiosa napoletana, che alla Harvard University si occupa di Visual and Environmental Studies, tesse una serie di relazioni tra arte, architettura, moda, cinema, fotografia e design e propone di considerare l’oggetto visuale secondo una prospettiva multipla a partire dalla sua specifica concretezza tangibile, spaziale e ambientale. Nelle pagine in cui si articola il suo studio teorizza, pertanto, un nuovo materialismo, convinta pure che «la materialità non riguardi i materiali, bensì la sostanza delle relazioni materiali» (p. 16). Suggerisce pertanto un approccio aptico alle arti visive molto vicino alla percezione tattile già teorizzata da Riegl.
Il saggio di Giuliana Bruno è corposo e stratificato, le parti si assemblano e si intersecano senza tendere a un climax argomentativo. Le quattro sezioni del libro sono concepite come blocchi indipendenti ma finiscono col ripiegarsi l’una sull’altra, si rincorrono tra cuciture e risvolti e non rinunciano a una scrittura dialogica, più empatica che accademica, come dimostra in chiusura la lettera ‘virtuale’ a Sally Potter. L’aspetto tematico che sostiene il discorso, sin dalla prima sezione I. Trame del visuale, è la «tensione di superficie». La superficie, che richiama la texture e la sartorialià, rinvia alla seconda pelle dell’uomo, l’abito, alla pellicola cinematografica e dunque alla pelle di tutte le cose. Correlando i plissè di Issey Miyake alla Piega di Gilles Deleuze, Bruno analizza il cinema di Wong Kar-wai che è una questione di filosofia sartoriale, dove il vestire, oltre il coprire, sa diffondere «atmosfere mentali» (p. 51). Cucire un abito o una striscia di celluloide è un gesto di sartorialità del campo visivo.