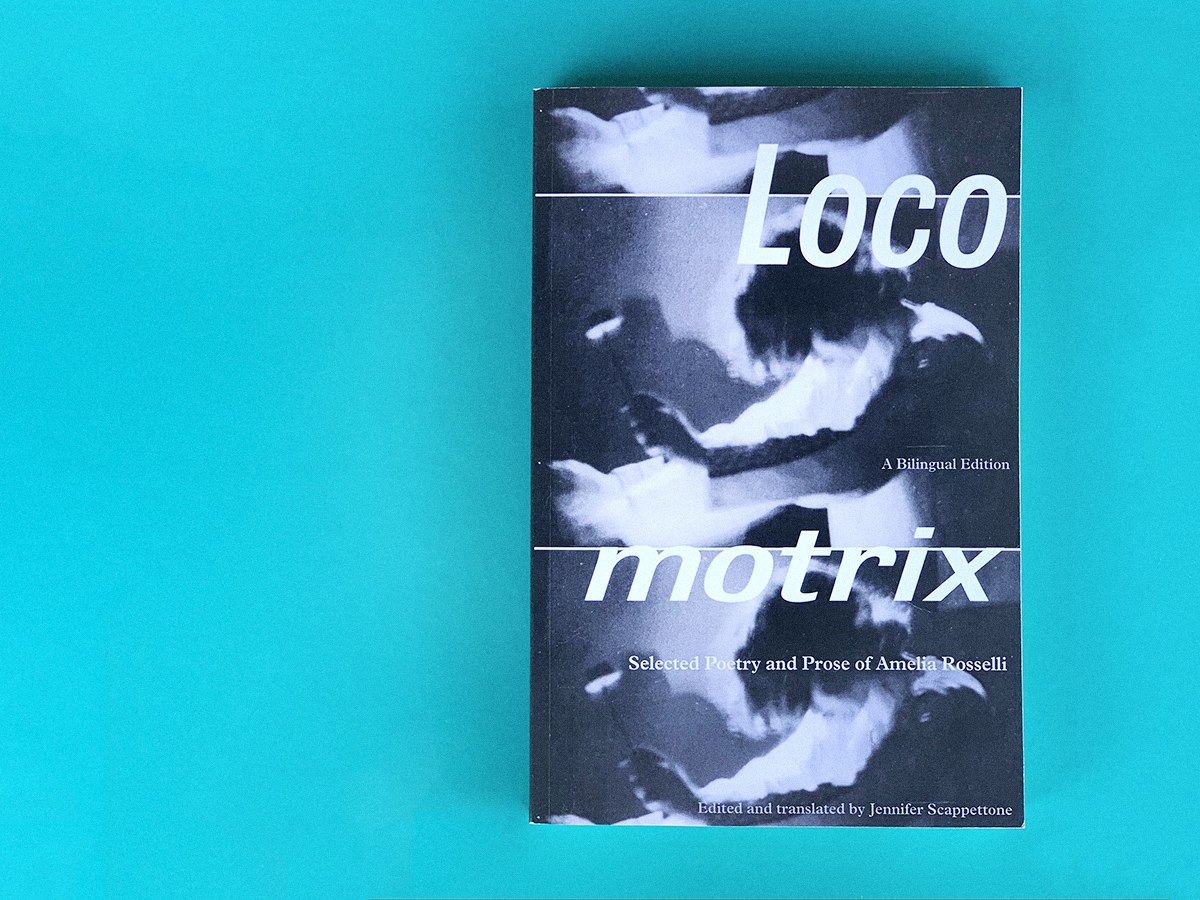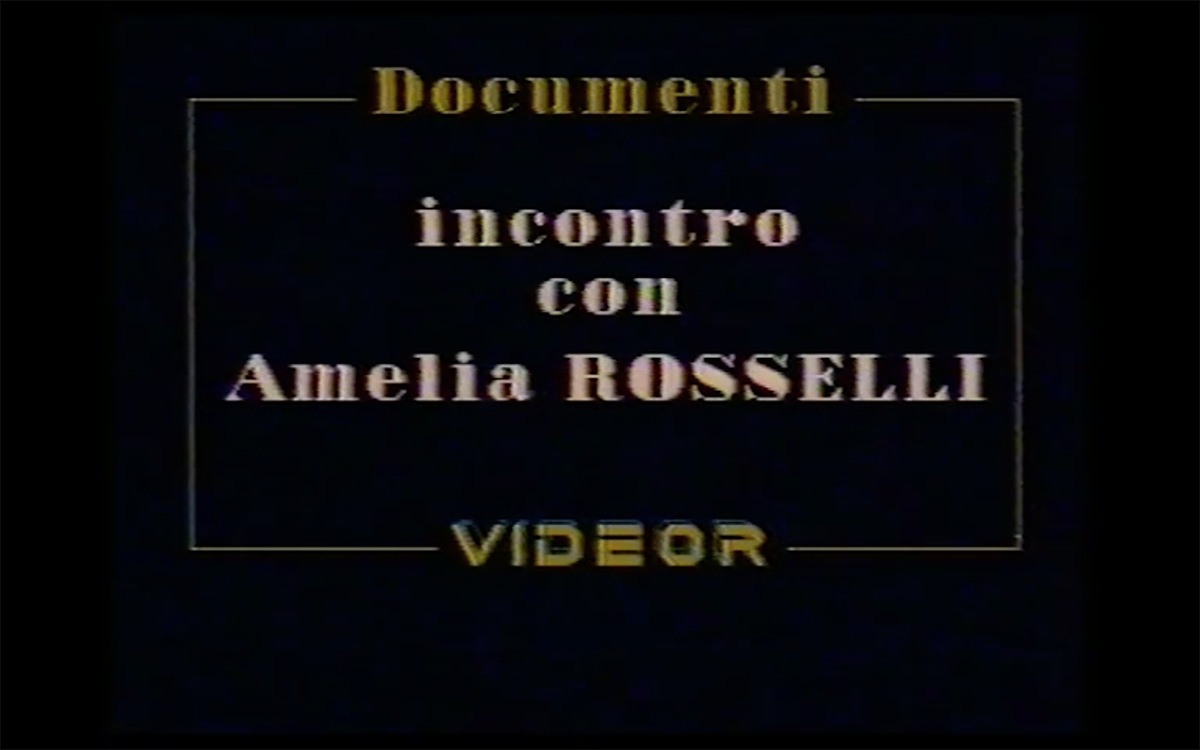I rapporti tra Elsa de’ Giorgi e il mondo dell’arte sono avvenuti in maniera direi quasi naturale nel corso della sua precoce e lunga carriera, appunto, artistica. Se già con la parola ‘artista’ si potrebbe definire chi, come nel caso della de’ Giorgi, sia riuscito con serietà, e una certa grazia, a interpretare più ruoli tra cinema, teatro e letteratura.[1]
Ma basterebbe pensare alle amicizie, le frequentazioni, le vicissitudini sentimentali che l’attrice e scrittrice, nata a Pesaro il 26 gennaio del 1914, ha saputo coltivare con tantissime personalità del grande sistema delle arti. E dico sistema delle arti perché i nomi propri che si avvicendano, direttamente o indirettamente, nella sua vita sono quelli di Carlo Levi, Leoncillo, Guttuso, Pier Paolo Pasolini, Bernard Berenson, per stare solo a qualche esempio. E dunque pittori, scultori, registi, scrittori, critici, storici dell’arte. Di ciascuno di loro Elsa comprende lo stile, la poetica, la filosofia e quindi la qualità, il livello, la grandezza. Mi pare che sia questo ciò che più sorprende di quest’autrice.
Elsa de’ Giorgi non è una testimone di un bel periodo storico, non una sopravvissuta e né una marginale spettatrice di un’età dell’oro della cultura italiana (come spesso hanno voluto perimetrarla i suoi detrattori). Elsa de’ Giorgi ha una dote innata: è munita di un gusto sicuro, una sorta di radar per i valori dell’arte che sa riconoscere, comprendere e riversare in tutto ciò che fa, nel suo lavoro: sublimando la citazione in gesto critico.