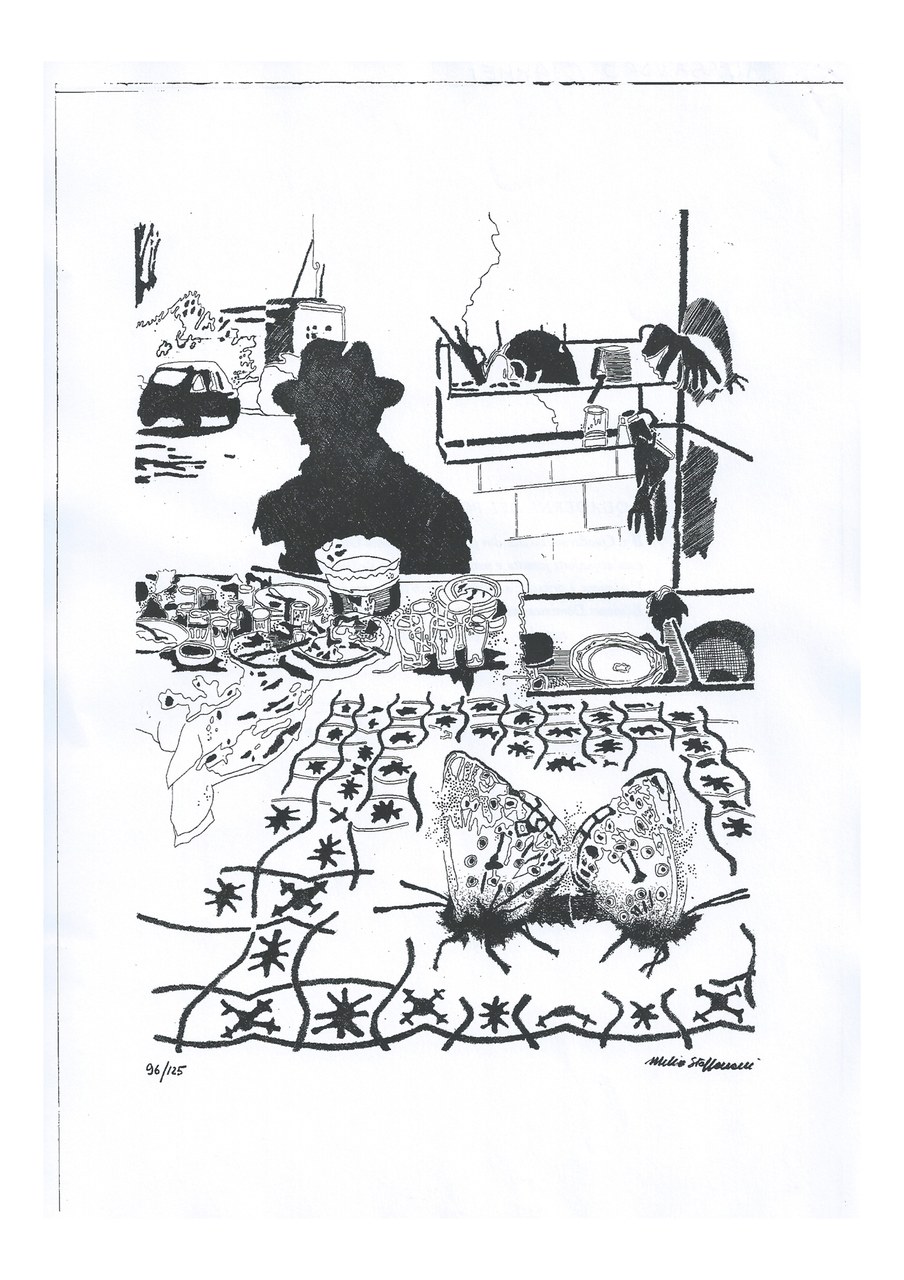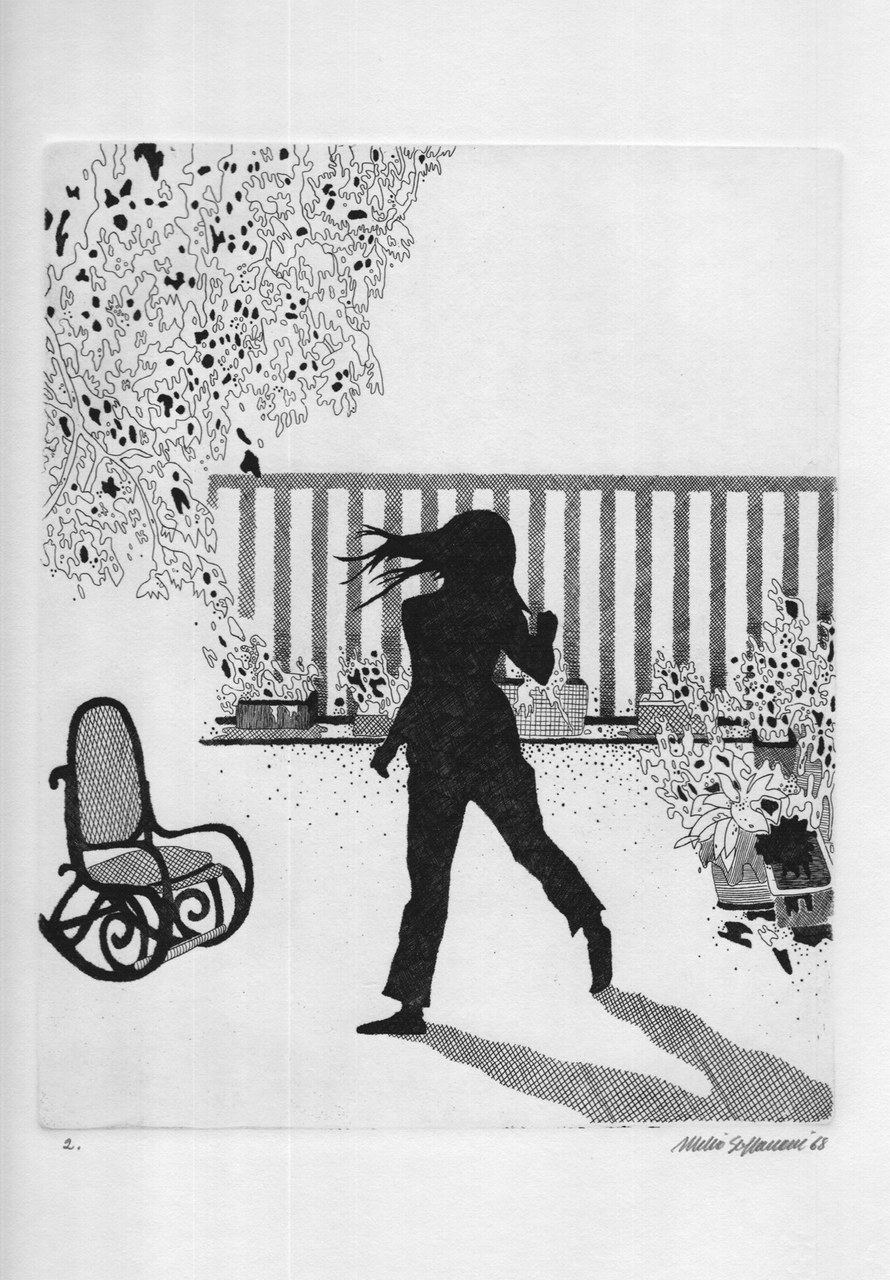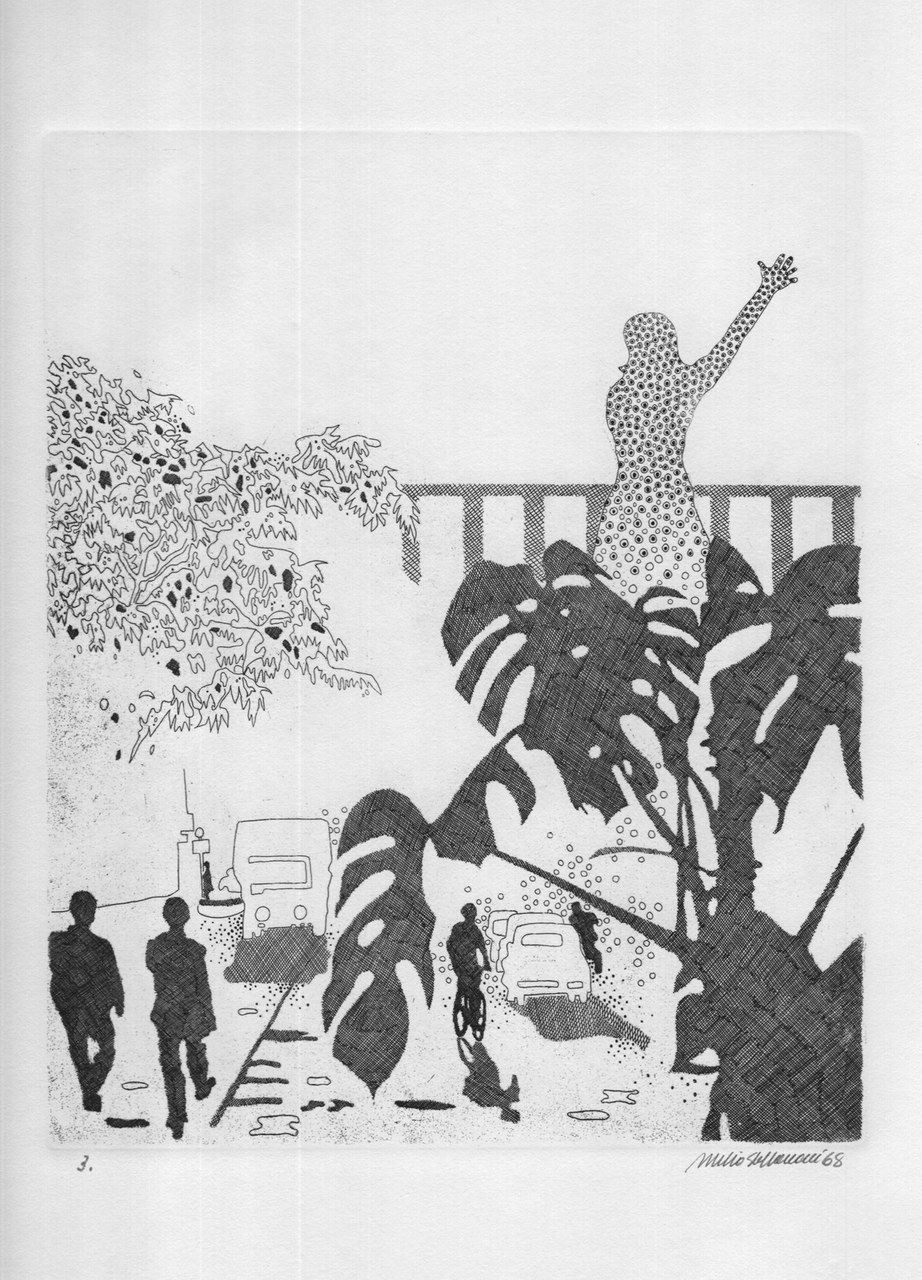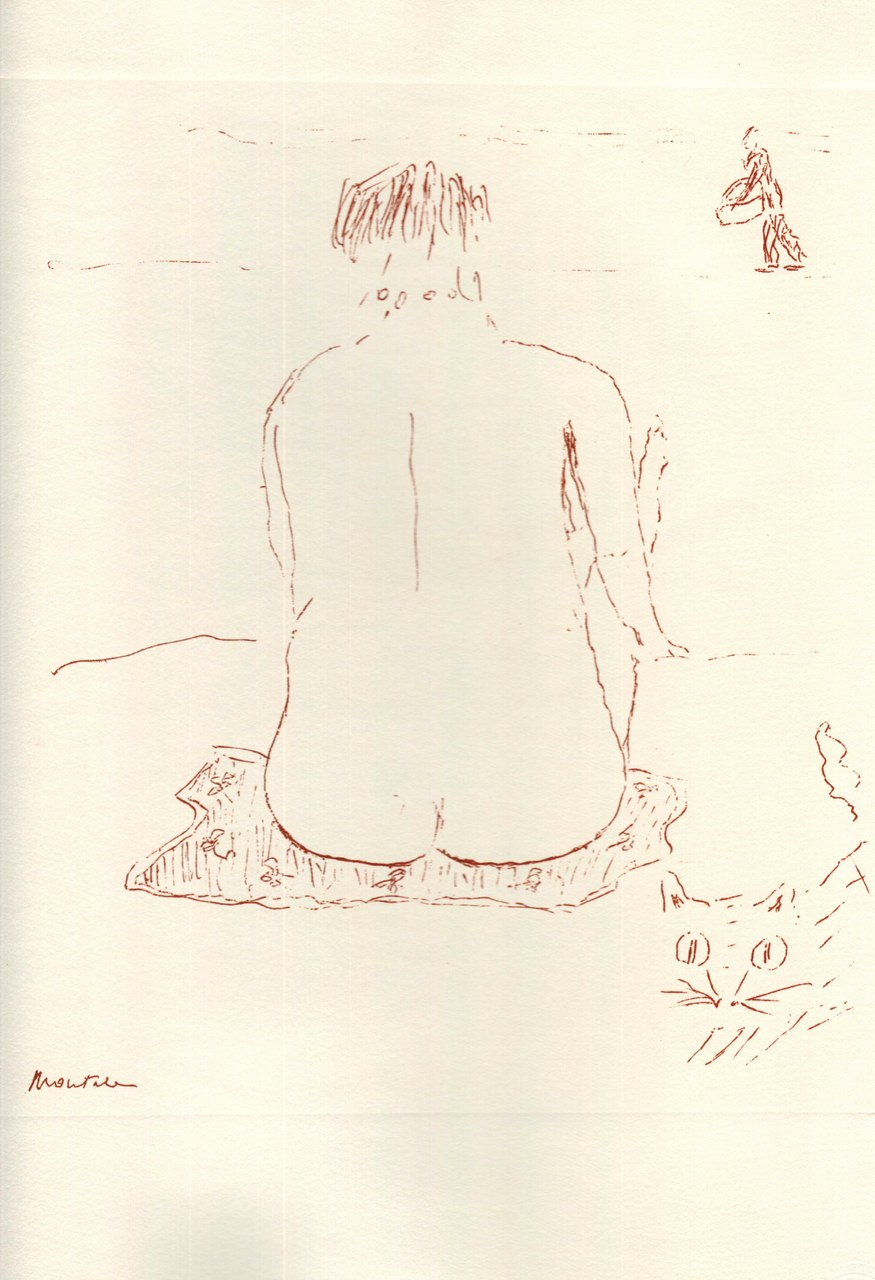La compagnia Anagoor, sempre attenta nelle sue creazioni all'indagine sulla lingua e alle molteplici rifrazioni del passato nel presente (si pensi a Lingua Imperii ma anche al più recente Virgilio Brucia), solca le impervie vie della poesia pasoliniana con una nuova produzione. La scelta ricade non a caso sull'Italiano è ladro di Pier Paolo Pasolini: un poemetto plurilingue, dalla marcata connotazione politica, a cui Pasolini lavora durante la fervida e per certi aspetti controversa stagione degli anni Cinquanta.
Lisa Gasparotto: Un po' per caso, qualche tempo fa, mi hai chiesto di consigliarti una lettura pasoliniana: ti ho subito suggerito L'italiano è ladro, un testo poco noto ma cruciale, secondo me, nell'ambito dell'esperienza letteraria ma anche politica e umana di Pasolini. Tu hai così scelto senza esitazione di accogliere quella proposta, realizzando il 2 novembre 2015 una prima mise en espace, con pochi amici ad assistere: «per ricordare», hai detto. In quella prima occasione la scelta fu quella di portare sulla scena la lettura integrale della cosiddetta Redazione Falqui, la redazione più lunga del testo (accessibile al lettore perché pubblicata postuma nel Meridiano Mondadori), e un mio intervento critico, per accompagnare e mediare quindi l’ascolto di questi versi. A te e a tutti noi (ma anche al pubblico amico presente) è parso subito evidente si potesse iniziare a lavorare a una lettura scenica. E così è stato. D'altro canto la struttura teatrale e drammaturgica dell'Italiano è ladro, sebbene nel non-finito, è piuttosto marcata. Cosa dunque ti ha colpito inizialmente di questo testo? Forse la matrice tragica dei cori o quel pianto, corale e quindi ancestrale, delle madri? O invece, la riflessione pasoliniana sulla lingua, quella lingua del potere e del dolore su cui anche voi vi soffermate nelle vostre creazioni?