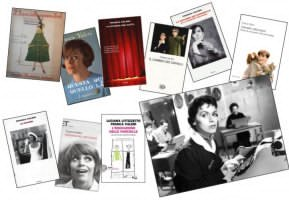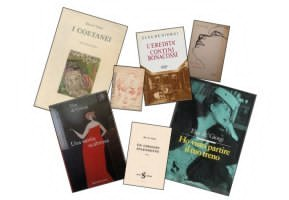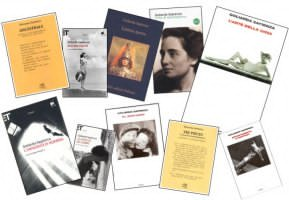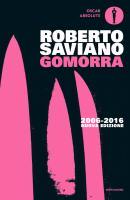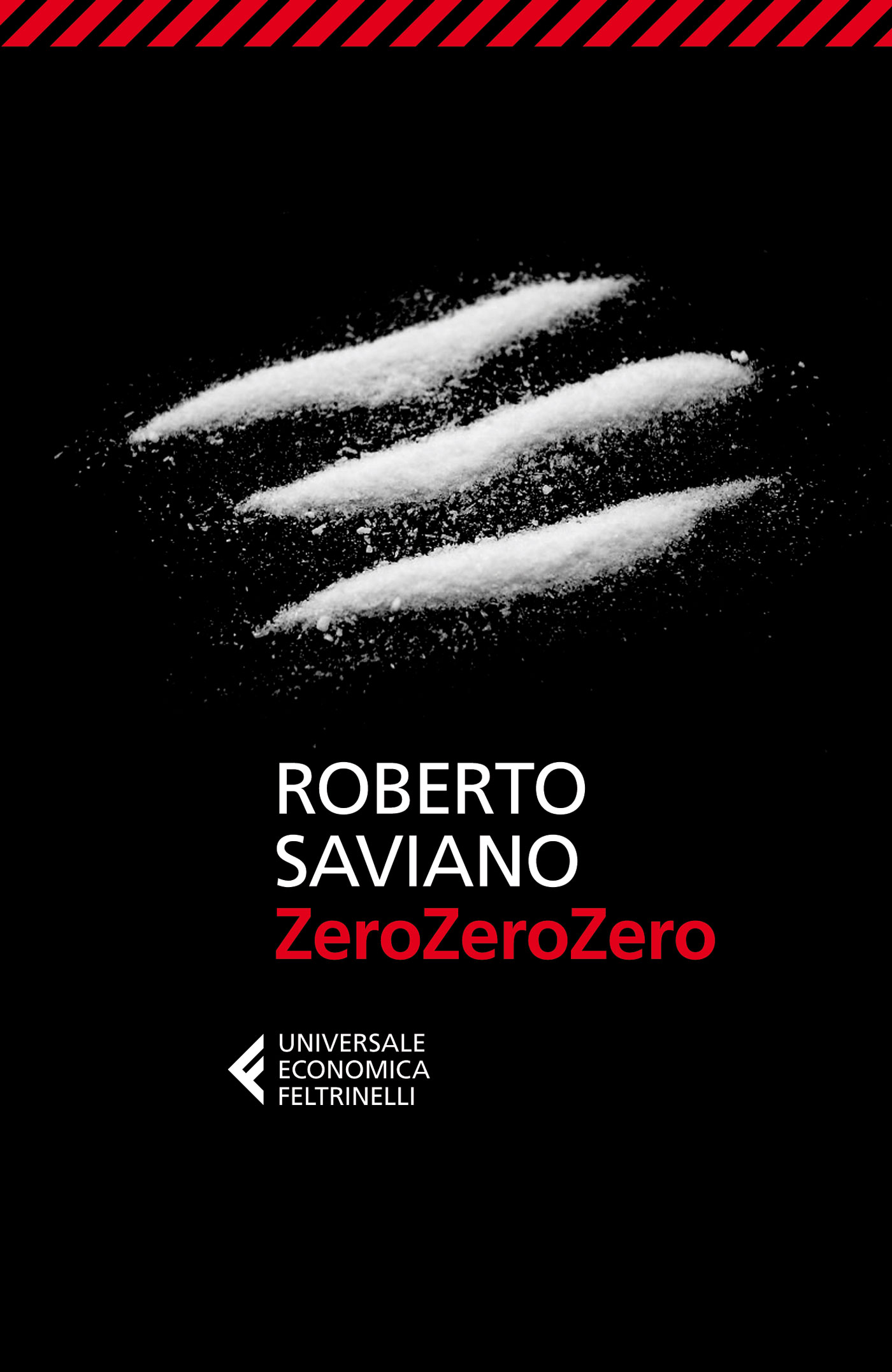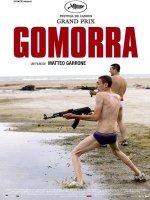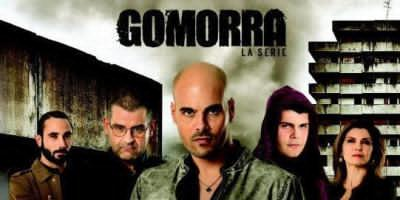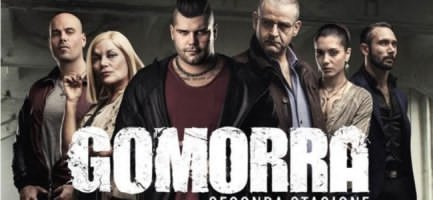1. «Prima la donna»
Entriamo subito nel cuore della recensione: la mostra Lyda Borelli primadonna del Novecento, attualmente in corso presso la Galleria di Palazzo Cini a Venezia (chiuderà i battenti tra pochissimo, il 15 novembre), merita di essere visitata perché ci restituisce il profilo di una donna e di una artista del «nostro tempo», che non è solo quello dei primi anni Dieci del secolo scorso, secondo quanto ricorda Mario Carli nella citazione in esergo tratta da una dedica presente nel romanzo Retroscena del 1915, ma è anche quello del nostro presente, ovvero degli anni Dieci del nuovo secolo. Certo l’immagine e la fama di Lyda Borelli sono indissolubilmente legate all’Italia che si preparava e poi affrontava la Grande Guerra, che era attraversata da sussulti modernisti e iniziava a conoscere grandi trasformazioni negli stili di vita, nell’organizzazione urbana, nelle manifestazioni artistiche. Si tratta tuttavia di aspetti che altre mostre e altri libri si sono già presi il compito di rammentare in precedenti circostanze.
Il merito della personale curata da Maria Ida Biggi, e fortemente voluta dall’Istituto per il Teatro e per il Melodramma della Fondazione Giorgio Cini, è invece quello di aver cercato di compiere un passo in avanti, valorizzando gli aspetti della vita dell’attrice spezzina che parlano anche agli spettatori e alle spettatrici di oggi. Già conoscevamo Borelli per essere stata la più celebre Salomè dei palcoscenici italiani e, forse ancor di più, per essere stata, con Francesca Bertini ed Eleonora Duse, una delle più famose dive del cinema muto internazionale; l’allestimento della Galleria di Palazzo Cini ci restituisce invece una donna a tutto tondo, dove accanto a preziosi materiali dell’epoca che ne documentano il successo professionale (stampe, locandine, recensioni, fotografie di scena) ne emergono altri, altrettanto eterogenei (quadri, costumi, fotografie, vetrini, sculture e molto altro), che esaltano invece la sua straordinaria consapevolezza, contemporanea appunto, nei modi di essere e di apparire, nelle condotte sociali da adottare e nelle passioni da coltivare, fuori e dentro i teatri di posa o i palcoscenici teatrali.










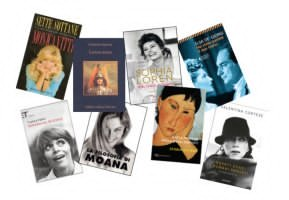
![Sophia Loren, In cucina con amore [1971], Milano, Rizzoli, 2013.](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xrizzarellim_attrici_g_fig3.png.pagespeed.ic.ihmGxVz6lQ.jpg)
![Foto tratta da Sophia Loren, In cucina con amore [1971], Milano, Rizzoli, 2013.](http://www.arabeschi.it/uploads/Nx200xrizzarellim_attrici_g_fig4.png.pagespeed.ic.Zwxc4_gfkl.jpg)