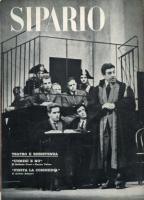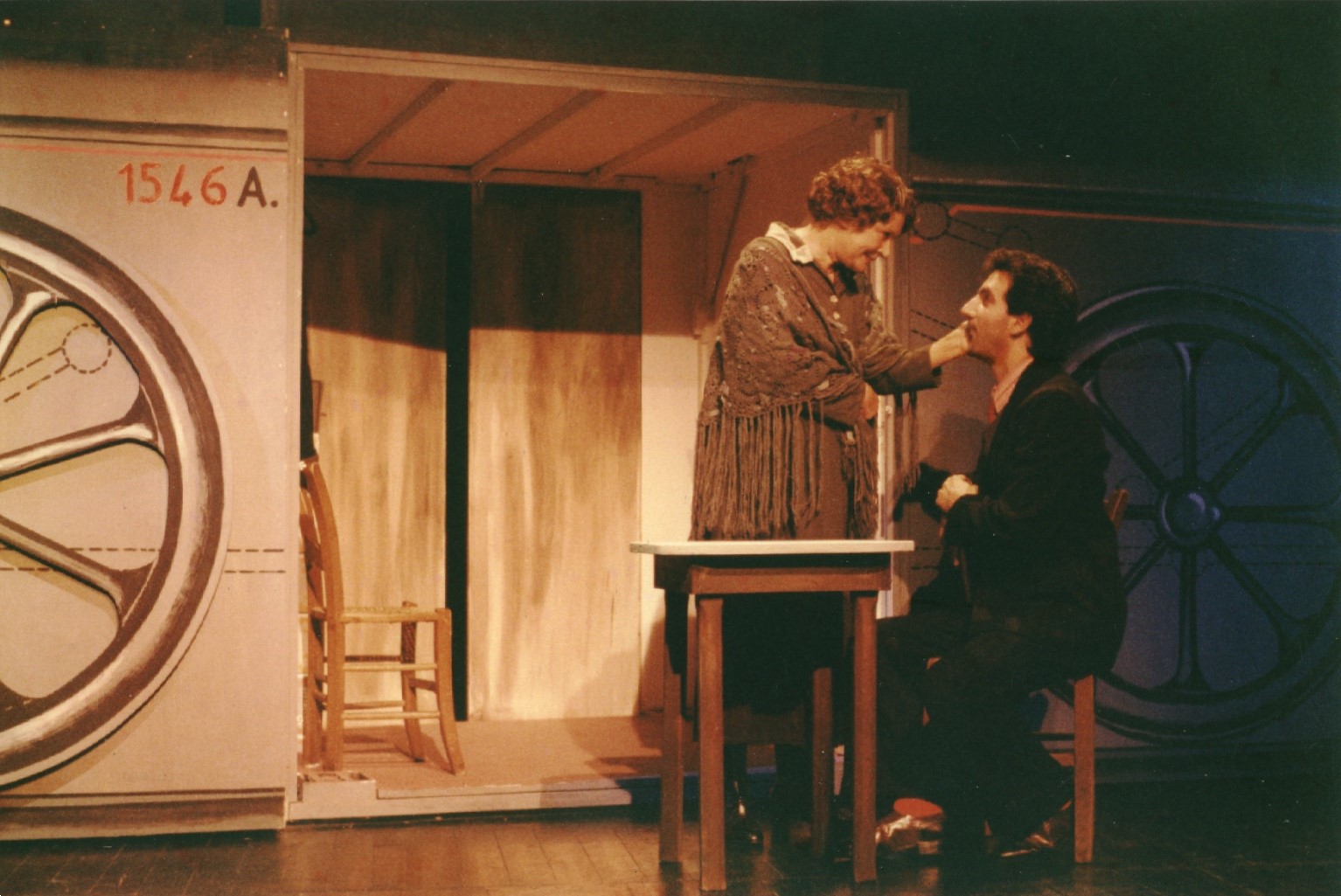D: Partirei proprio dal ‘qui e ora’. Ci stiamo incontrando all’interno della stagione estiva del Teatro Stabile di Catania che vede il debutto del vostro ultimo spettacolo Marionette, che passione! da Rosso di San Secondo. Voi che vivete e lavorate a Messina, che sguardo avete sulla vostra città? E, sempre da un punto di vista culturale, come appare ai vostri occhi Catania e il legame tra queste due sorelle – se sono davvero da considerarsi sorelle – nella costa orientale della Sicilia?
R: Anzitutto siamo molto contenti di questa domanda, perché rappresenta per noi il focus su cui le istituzioni dovrebbero cominciare a ragionare in maniera intelligente, facendo quella che sempre viene chiamata ‘rete’ ma che sembra così difficile in un contesto come quello siciliano. Riteniamo questa, veramente ‘qui e ora’, un’occasione che probabilmente dovrebbe caratterizzare le esperienze dei cosiddetti ‘giovani’ che non sono più giovani, che hanno un percorso alle spalle di dieci anni e che comunque vogliono potere sperimentare quello che qui è accaduto, cioè avere una macchina istituzionale messa a loro disposizione con fiducia e meraviglioso rischio. Perché la felicità, ma al contempo anche l’arte, è rischio e rischio equivale anche a responsabilità: noi, con tutta la squadra, ci sentiamo estremamente responsabili e di questa responsabilità ne facciamo un valore. Vogliamo, però, che questo rischio – che è stato assunto da Catania nella figura straordinaria di Laura Sicignano – sia un punto d’esempio per tutta la Sicilia. Perché noi ci sentiamo onorati di potere intraprendere una cosa che ti mette d’innanzi a tutta una serie di elementi con cui in genere non siamo soliti operare: abbiamo sempre giocato e lavorato con una povertà del teatro e qui continuiamo a ragionare sulla povertà del teatro – e sulla magnificenza di quella povertà –, sapendo però di potere contare su una struttura che evidenzia che cos’è il teatro. Il teatro è povero, deve rimanere povero, ma si deve avvalere della forza degli esseri umani, perché amplifica la loro potenza per poi raccontare la nullità del genere umano. Messina è in un momento di grande disvalore culturale, che rischia un impoverimento delle generazioni a venire. Se non si vede teatro, se non si cerca di creare, appunto, delle connessioni, le generazioni non si incontrano e non possono poi arrivare a dire quello che si costruisce nel tempo, piano piano, con l’esperienza. E si può cominciare a dire che questa è un’occasione di grande esperienza che fuoriesce dai canoni che eravamo abituati a sperimentare.