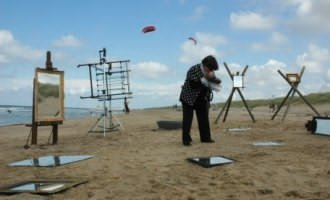Le parole di Suso Cecchi D’Amico poste in esergo offrono un ritratto di Anna Magnani in cui la lucida obiettività di talune affermazioni («non era bella […] le gambe erano magre e leggermente storte […]») viene del tutto sopravanzata dal tono poetico e immaginifico della descrizione («spesso cupa come il suo cane lupo color dell’ebano […]»), e dal suo chiudersi sull’improvviso emergere di tratti di splendore («aveva un décolleté splendido, come pure lo erano le mani e i piedi […]»), sino alla resa incondizionata di fronte al suo fascino («Dovunque entrasse in scena, non guardavi altri che lei»). Un ritratto delineato da parte di qualcuno che proprio scrivendo per lei, in qualche modo Ê»di leiʼ, aveva sviluppato con l’attrice e la donna un rapporto di profonda intesa e amicizia, durato molti anni e rievocato in numerose occasioni. Un’amicizia fatta di fiducia, in particolare da parte della Magnani nei confronti di Suso, che confidava nella scrittura della sceneggiatrice, avvertendola rispettosa della sua personalità più che dello stereotipato personaggio Ê»Magnaniʼ e, soprattutto, delle sue qualità di attrice, spesso previste, anticipate, ma mai imposte nei ruoli scritti per lei; una collaborazione che inizia con L’Onorevole Angelina (L. Zampa, 1947) e prosegue con Bellissima (L. Visconti, 1951), Camicie rosse (G. Alessandrini, 1952), l’episodio Anna Magnani (L. Visconti, 1953) in Siamo donne, Nella città l’inferno, di cui si parlerà in questo contributo, e che si conclude con Risate di gioia (M. Monicelli, 1960). Ma se sono note le tappe di un rapporto che conosce una fase calante proprio in concomitanza con l’ultimo film di Monicelli, e che si nutre del sodalizio artistico ma anche di quello umano (con la Magnani che coinvolge l’amica nelle sue crisi sentimentali, nelle incomprensioni con i registi, nelle sue partenze – quella per l’America –, nelle sue Ê»ruzzeʼ notturne), non sempre sono state osservate nel dettaglio le relazioni tra la scrittura dell’una per l’altra, e la performance dell’attrice.