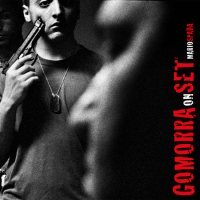Oggetto d’indagine del recente studio di Michele Cometa, Il Trionfo della morte di Palermo. Un’allegoria della modernità, pubblicato a luglio 2017 per Quodlibet, è, come suggerito dal titolo, il meraviglioso quanto misterioso affresco palermitano, che, eseguito intorno alla metà del XV secolo da due pittori tutt’ora sconosciuti per il cortile dell’Ospedale Grande e Nuovo in Palazzo Sclafani, si trova oggi conservato presso la Galleria Regionale di Palazzo Abatellis di Palermo.
Ciò che propone Cometa in questa sede, mettendo da parte i già consolidati strumenti di ricerca degli storici dell’arte, è un nuovo approccio di analisi all’opera che affonda le sue radici sia nei paradigmi della cultura visuale contemporanea, sia nelle considerazioni proprie della storia dei concetti teorizzata da Koselleck. L’autore così, invece di «dissezionare in brandelli» l’opera, preferisce porsi in ascolto della polifonia di voci e di sguardi che la compongono, con l’obbiettivo di connettere queste varie tessere visive e ricercarne l’armonia di fondo, la quale, costruita su una fitta trama di relazioni, a saperla guardare, prenderebbe la forma di un vero e proprio intreccio narrativo. Il racconto, interamente affidato al muto dialogo messo in scena tra i personaggi e tra questi e lo spazio che li ospita, si srotola come in una giostra in curve ed ellissi, illustrando gli atteggiamenti e le sfumature dell’animo umano, Stimmungen come le definisce Cometa, che si manifestano al sopraggiungere della morte. È proprio la necessità di questa storia l’unico antidoto che rimane all’uomo contro la dissoluzione della vita.