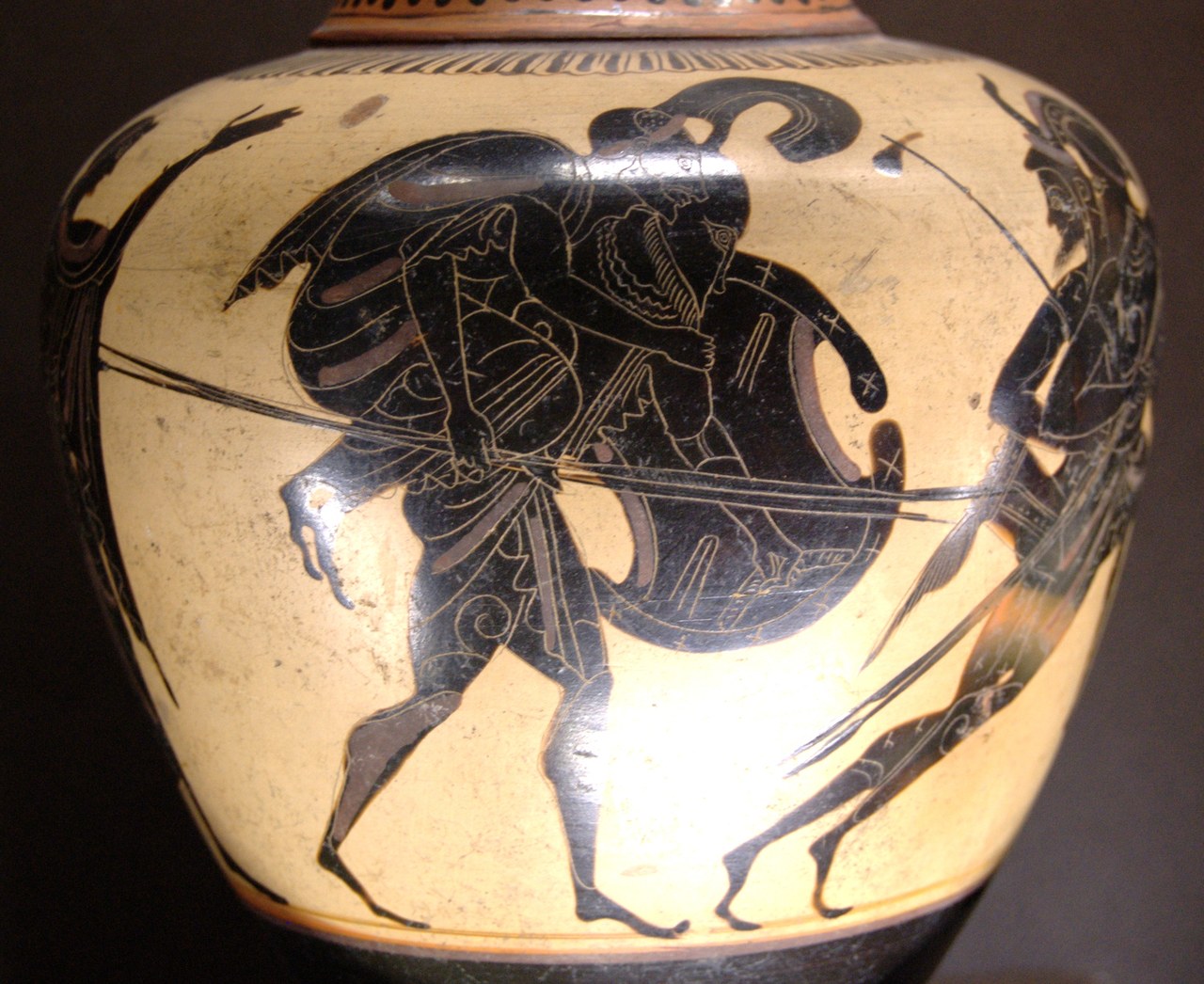In Caïn, la dieresi che segna la i corrisponde a una specie di ghigno, un apparire di fauci che mette allo scoperto due canini appuntiti che spiccano sugli altri denti.
Michel Leiris, Biffures
Quando mi sono affacciato alla finestra, sul tetto di fronte c’era un corvo con la testa rientrata, nella pioggia, e non si muoveva. Un sentimento di fratellanza mi ha invaso e il cuore mi si è riempito di solitudine.
Werner Herzog, Sentieri nel ghiaccio
1. Svuotare il sacco
Nessun giudice, nessun arbitro, nessun padre. Solo due lottatori. Lasciati soli sul ring. Lasciati soli a negoziare la propria (in)dipendenza. Nel tempo dei loro gong, tra le urla e i fischi di una platea invisibile. Forse perché nella trasgressione di un divieto, sulla scena dell’origine, non si può che agire soli.
Il doppio duetto sul mito biblico di Caino e Abele che Roberto Zappalà e Nello Calabrò hanno realizzato con Liederduett (Bolzano, luglio 2018), convergendo le due parti, già autonome, «in un nuovo allestimento con nuove musiche e un nuovo set scenico», di Corpo a corpo (Catania, marzo 2018) e Come le Ali (Viagrande, maggio 2018), è un monito sulla sventura di ogni ritorno della figura del padre.
Il coreografo catanese è persona devota, penso anche religiosa in senso minimamente osservante ma, almeno nei suoi lavori, pure in quelli maggiormente legati alla spiritualità della sua terra (fra tutti, per esempio, A. semu tutti devoti tutti? del 2009), senza alcuna rivendicazione confessionale. Anzi. In un precedente lavoro, La Nona (dal caos, il corpo) del 2015, l’esigenza di una maggiore comunanza spirituale per l’umanità intera gli faceva mettere in compresenza, fra gli oggetti di scena, tutte le rappresentazioni e i simboli ermeneutici di ogni paradigma religioso.