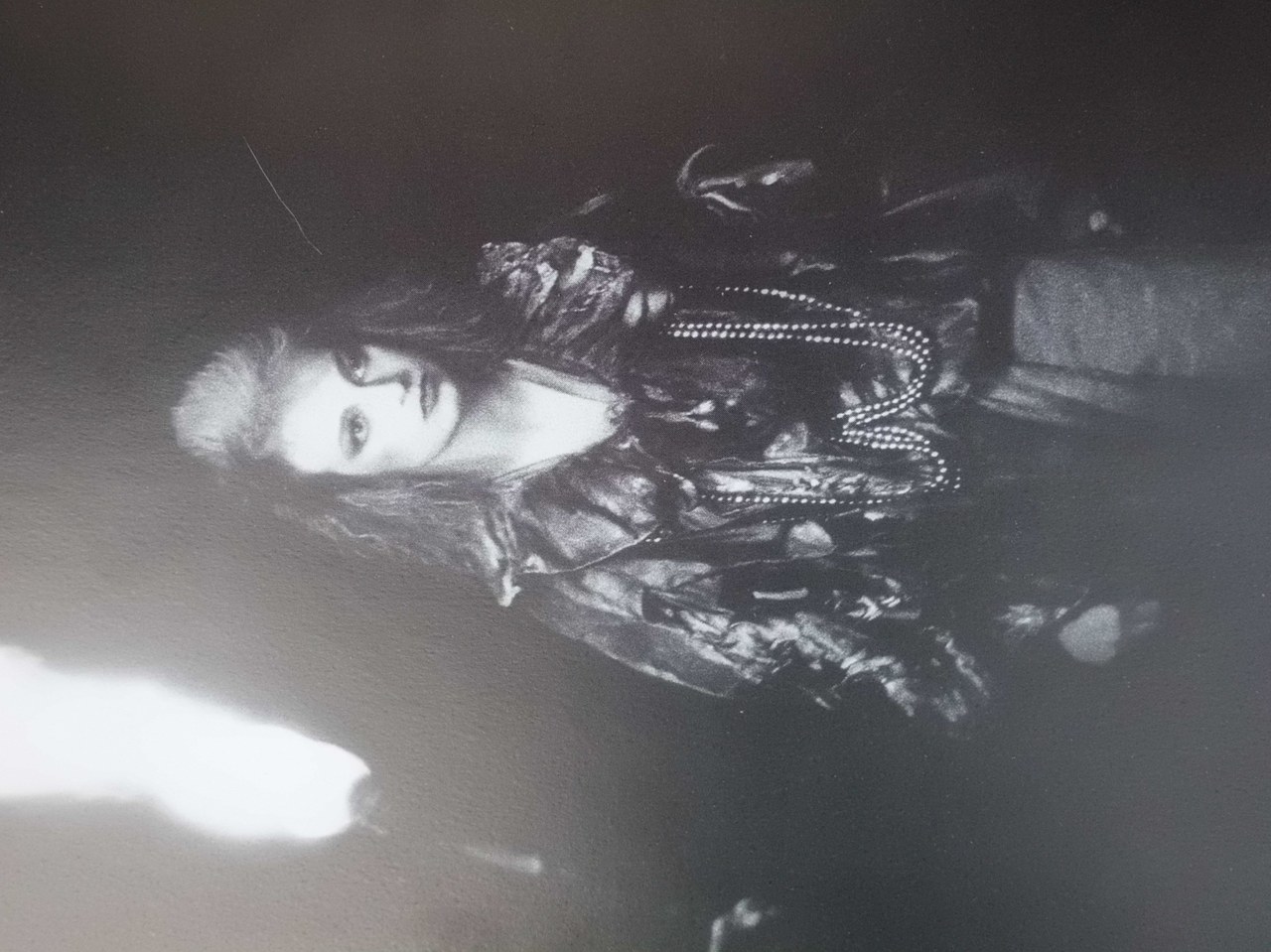Studiare il corpo (e i corpi) al cinema significa anzitutto considerare due distinte, sebbene interrelate, dimensioni. Da una parte, i film (e in generale i prodotti audiovisivi) rappresentano i corpi: li traducono, cioè, in immagini visive e sonore costruite attraverso molteplici forme di sguardo, caricandoli di significati di volta in volta differenti, e proiettandoli fuori dal mondo fisico e carnale e dentro un universo di fantasie, modelli e repertori immaginari. Dall’altra, i corpi sono anche (e soprattutto) una delle materie principali attraverso cui il cinema, la televisione e le arti elettroniche formano e sviluppano il loro discorso, la loro “parola audiovisiva”: pensiamo, ad esempio, a come i gesti e le voci degli attori e delle attrici partecipino alla produzione e alla messa in forma del racconto nel cinema narrativo, a come la performance corporea stia spesso alla base delle sperimentazioni videoartistiche; o ancora alla centralità assoluta del corpo (parlante, danzante, cantante, in ogni caso “presente”) che ha caratterizzato la comunicazione televisiva fin dalle sue origini.
Pensare il corpo negli scenari mediali obbliga a misurarsi con un oggetto visibilissimo ma intimamente sfuggente. Allo stesso tempo portatore e produttore di senso, il corpo cinematografico si impone come rappresentazione (e, dunque, come incarnazione di una pluralità di significati sociali, culturali, autoriali, e così via) e insieme come entità performativa, capace di creare significati attraverso la propria fisicità.