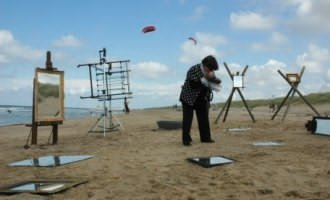Quando un’opera sembra in anticipo sulla sua epoca, semplicemente la sua epoca è in ritardo su di lei.
J. Cocteau
Nell’apparente instabilità epistemologica degli ultimi tre decenni dalla teoria alle ‘teorie del cinema’, la pubblicazione del volume Jean Cocteau. Teorico del cinema da parte della casa editrice Mimesis nel 2018 poteva sembrare solo un’operazione storico-retrospettiva. Il lavoro di Stefania Schibeci, docente di Pittura e Arti del XX, è la prima monografia italiana sul tema dedicata all’artista ma getta le basi per un ponte verso il quadro teorico del secondo Novecento e in parte verso quello contemporaneo.
L’attualità della pubblicazione è legata senz’altro alla scelta della figura di Cocteau: poeta, pittore, drammaturgo, romanziere, disegnatore, pittore, regista, attore, ecc. Una personalità che ha incarnato l’apertura interartistica del secolo scorso e anticipato ‒ come sembra emergere da questo contributo ‒ alcune riflessioni teoriche successive di tipo filosofico, fenomenologico e mediale intorno alle immagini in movimento. Anche se si avverte, forse, la mancanza di alcune connessioni suggerite al lettore proprio da alcuni temi affrontati nel testo. Riprendendo, per esempio, gli elementi centrali della sua teoria sul cinema come veicolo insieme alle altre arti della «poésie» (p. 11), conoscenza del mondo attraverso la soggettività del poeta, e la sua specificità come scrittura per immagini capace di «rendere visibile l’invisibile» (p. 13), sarebbe stato interessante accogliere tra le pur ricche relazioni del testo somiglianze e differenze con le idee di Pasolini da un lato e con la filosofia di Merleau-Ponty dall’altro.